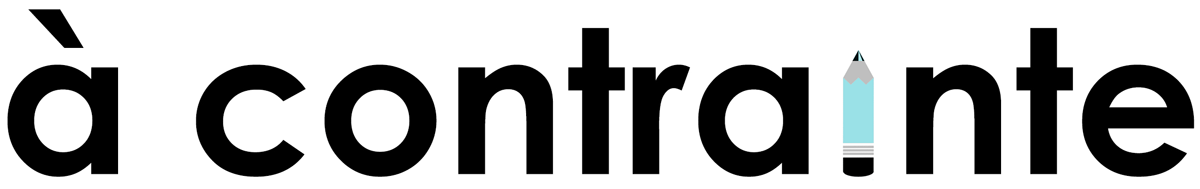Mi è capitato, di recente, di camminare ed essere folgorata da un pensiero: «Michele Serra lo scrive sempre nella sua biografia!». Stavo infatti meditando sul fatto, apparentemente straordinario, che dopo anni di lotte e delusioni oggi posso dire anche io che di lavoro scrivo, e mi pagano per farlo. Il fulcro del ragionamento è in realtà la presa di consapevolezza di una sconfitta: non scrivo per un giornale, non sono la firma di nessuna testata. E allo stesso tempo non sono una scrittrice, la mia firma non è associata a una produzione di narrativa. Ci ho provato, ci riproverò, ma ormai ho capito che questi mestieri non andranno a disegnare una carriera coerente e compatta.
Perché io faccio parte di quel gruppo di millennial della prima ora – quelli nati negli anni ’80 – che hanno surfato l’onda del cambiamento enorme del digitale, lo hanno visto arrotolarsi prima che si scatenasse e rivoluzionasse il mondo, ma intanto sono rimasti fregati. Mondo del lavoro, specialmente per le professioni della comunicazione, sbriciolato, contratti spezzettati, dai co.co.co alle finte partita iva e avanti coi carri, carriere impossibili, vita molto stressante. Conclusione? Reinventarsi come freelance.
E così uno si ritrova a trent’anni a rivedere tutto e capire che sì, inutile sventolare una laurea di un decennio fa se nel frattempo McLuhan è andato in pensione e se quando hai discusso la tesi Facebook era agli albori. Inutile intestardirsi che vuoi fare il giornalista e scrivere, e basta. Ci vuole formazione, da un lato, apertura dall’altro. Ravvedute le mie idee – e i miei sogni – ho capito che il mondo della comunicazione, le famose scienze delle merendine con cui una parte di mondo ha sfottuto anni manco studiassi marionette e fenomeni da baraccone, è qualcosa di fluido, sempre più veloce, cangiante, schiacciante, anche, e bisogna cavalcarlo per capirci qualcosa e stare in giostra. Ho accettato lavori che non centravano il mio desiderio perfetto, è vero, ma ritrovandomi sulla suddetta giostra ho aperto gli occhi sulla necessità impellente di aggiornarmi, e formarmi per un mondo che rispetto “ai miei tempi” era decisamente cambiato.

Nella mia dieta di lettrice sono quindi entrati e rientrati testi di saggistica che hanno in larga parte contribuito a) a rassicurarmi: la confusione che percepisco nel mondo è reale b) a insegnarmi: ok, nonostante la confusione, qualcosa è possibile c) a rivalutarmi: a volte essere “antichi” ha i suoi vantaggi metodologici, l’importante è restare flessibili. Ecco quindi qualche manuale più o meno recente che consiglio a chiunque si affacci al mondo della comunicazione sperando di poterne uscire con una carriera, o almeno l’impronta di un percorso intorno al quale costruire un futuro lavorativo. Perché sì, lavorare scrivendo si può: basta sapere cosa scrivere e come, e tenere una lampadina metaforica sempre accesa per rendersi conto di cosa stiamo facendo, ma per davvero, e intercettare tutte le novità che funzioneranno da appigli e molle.
Le professioni del digitale
Partiamo da Franco Angeli e da una collana di manualistica che ritengo tra le migliori degli ultimi tempi. Si chiama Professioni digitali e la dirige Alberto Maestri. Il suo scopo, come chiaramente annuncia il nome, è occuparsi di quelle che vengono definite “professioni di domani”, ma che, parola mia, sono già le professioni di oggi, più o meno in nuce. I manuali di questa collana sono scritti da professionisti della specifica professione digitale in oggetto e, se non altro i due che ho studiato e apprezzato, sono un aiuto solido, concreto e assolutamente consapevole per atterrare pronti e corazzati in contesti lavorativi legati alla comunicazione.
 Ho scoperto questa collana con #PA Brand Expert, di Annalisa D’Errico e Gianluigi Bonanomi. Il sottotitolo del volume parla chiaro nella sua semplicità: “competenze e strumenti per i comunicatori della pubblica amministrazione”. Mi soffermerei, più che sugli strumenti – utilissimi a dire il vero – sulle competenze. Questo perché quando parliamo di PA in Italia intravediamo più o meno tutti un pachiderma arrugginito che cerca di fare manovra in cristalleria. Un disastro insomma. Non per fare i pessimisti e i negativi, perché in realtà esempi virtuosi e che segnano il passo esistono, e se ne fa menzione in questo libro, ma per capire tutto il mio stupore, e la mia gioia pura nel leggere che non sono sola in questa gestione di complessità più grandi di me. È così per tantissimi, e gli autori lo sanno. Ecco perché la parte secondo me più importante e nuova di questo libro è quella che approfondisce la necessità di un riconoscimento centrale per una professione, quella del comunicatore della PA, che negli ultimi decenni non è solo cambiata, è stata rivoluzionata! Solo dalla consapevolezza del quadro, del suo status, scaturirà poi una necessaria valorizzazione, professionale, contrattuale, economica. Gli autori informano che è in corso una riforma di legge che punta a istituzionalizzare le figure professionali del web nella PA con tutte le loro competenze necessarie ad affrontare questo mestiere ma ancora oggi, troppo spesso, misconosciute o non rilevate. Un libro, per me, determinate: lo straconsiglio a chiunque stia leggendo queste righe, anche e soprattutto per capire come funziona la comunicazione in una PA (e, di conseguenza, perché funziona o no).
Ho scoperto questa collana con #PA Brand Expert, di Annalisa D’Errico e Gianluigi Bonanomi. Il sottotitolo del volume parla chiaro nella sua semplicità: “competenze e strumenti per i comunicatori della pubblica amministrazione”. Mi soffermerei, più che sugli strumenti – utilissimi a dire il vero – sulle competenze. Questo perché quando parliamo di PA in Italia intravediamo più o meno tutti un pachiderma arrugginito che cerca di fare manovra in cristalleria. Un disastro insomma. Non per fare i pessimisti e i negativi, perché in realtà esempi virtuosi e che segnano il passo esistono, e se ne fa menzione in questo libro, ma per capire tutto il mio stupore, e la mia gioia pura nel leggere che non sono sola in questa gestione di complessità più grandi di me. È così per tantissimi, e gli autori lo sanno. Ecco perché la parte secondo me più importante e nuova di questo libro è quella che approfondisce la necessità di un riconoscimento centrale per una professione, quella del comunicatore della PA, che negli ultimi decenni non è solo cambiata, è stata rivoluzionata! Solo dalla consapevolezza del quadro, del suo status, scaturirà poi una necessaria valorizzazione, professionale, contrattuale, economica. Gli autori informano che è in corso una riforma di legge che punta a istituzionalizzare le figure professionali del web nella PA con tutte le loro competenze necessarie ad affrontare questo mestiere ma ancora oggi, troppo spesso, misconosciute o non rilevate. Un libro, per me, determinate: lo straconsiglio a chiunque stia leggendo queste righe, anche e soprattutto per capire come funziona la comunicazione in una PA (e, di conseguenza, perché funziona o no).
 Sull’onda della riflessione legata a figure professionali che mutano come muta il contesto – e lo fa assai velocemente, abbiamo visto, ho provato un altro volume della collana, quello dedicato al copywriting. Perché, se devo dire il vero, io mi sono ritrovata a fare del copywriting senza sapere di saperlo fare, sulla scusa del “tanto tu sai scrivere”. Ecco. Tra il saper scrivere e fare il copy ci passa un oceano, come quello che passa tra l’idea paludata del pubblicitario che raccontavano i miei manuali di comunicazione ormai agé e quello che fa un copy oggi, nel mondo digitale. Non a caso il volume che ho studiato si intitola Digital Copywriter, lo ha scritto Diego Fontana e si apre con la spiegazione del perché queste due aree – il copy e il digitale – vengano accostate. Intuitivo: oggi si scrive per il web, si è creativi per il web, si mettono le mani sul web, e se ne devono conoscere le regole, pur mantenendo attive tutte le altre competenze. La cosa bella di questo volume sono i consigli pratici, gli esempi che abbondano. La quarta di copertina lo dà per volume indispensabile per i professionisti ma anche per chi si affaccia oggi all’attività di copy. E io lo confermo, perché è davvero una guida di qualità.
Sull’onda della riflessione legata a figure professionali che mutano come muta il contesto – e lo fa assai velocemente, abbiamo visto, ho provato un altro volume della collana, quello dedicato al copywriting. Perché, se devo dire il vero, io mi sono ritrovata a fare del copywriting senza sapere di saperlo fare, sulla scusa del “tanto tu sai scrivere”. Ecco. Tra il saper scrivere e fare il copy ci passa un oceano, come quello che passa tra l’idea paludata del pubblicitario che raccontavano i miei manuali di comunicazione ormai agé e quello che fa un copy oggi, nel mondo digitale. Non a caso il volume che ho studiato si intitola Digital Copywriter, lo ha scritto Diego Fontana e si apre con la spiegazione del perché queste due aree – il copy e il digitale – vengano accostate. Intuitivo: oggi si scrive per il web, si è creativi per il web, si mettono le mani sul web, e se ne devono conoscere le regole, pur mantenendo attive tutte le altre competenze. La cosa bella di questo volume sono i consigli pratici, gli esempi che abbondano. La quarta di copertina lo dà per volume indispensabile per i professionisti ma anche per chi si affaccia oggi all’attività di copy. E io lo confermo, perché è davvero una guida di qualità.
Ciò di questi manuali Franco Angeli che ho apprezzato non sono solo gli utilissimi riferimenti, nonché gli esercizi e le bibliografie, ma la spiegazione di una complessità che credevo di percepire solo io, sentendomi spesso fuori luogo. No, questi libri ci dicono espressamente che è normale essere confusi davanti a un panorama digitale impazzito, rivoluzionato quotidianamente dalla stessa rivoluzione che ha acceso e innescato in un mondo che conosceva solo carta e inchiostro. Restare aggiornati con i consigli di questi volumi è dunque un grande aiuto per districarsi in questa selva e intravedere le opportunità che l’orizzonte potrebbe offrire. Ecco perché si tratta di letture che consiglio anche ai freelance come me: noi di questa categoria bellissima e insieme sfigata abbiamo bisogno di essere elastici, pronti, scattanti e aperti a tutto: stare sul pezzo è la cosa essenziale, e studiare è un’ottima via per riuscirci. Qui trovate qualche info in più sulla collana di Franco Angeli dedicata alle professioni digitali.
Cose digitali per umanisti
 Digitale, si è detto. C’è un altro manuale che consiglio a chiunque voglia affacciarsi, da ex studente di scienze della comunicazione, a qualsiasi lavoro col digitale. Dico a qualsiasi perché quando l’ho letto ho proprio pensato “ah, se lo avessi letto prima, quante ansie e dubbi in meno”. Parlo di Content Design. Progettare contenuti web che fanno incontrare persone e aziende, lo ha scritto Nicola Bonora per Apogeo e io lo ringrazio. Primo: perché mi ha fornito degli strumenti pratici molto interessanti, secondo, ma forse in verità sarebbe il punto da mettere davanti a tutti, perché anche in questo caso mi ha rassicurato sul mio ruolo, i miei studi, la mia funzione in contesti lavorativi che “hanno a che fare con la comunicazione”. È un manuale che risponde alla perfezione alla domanda “ma che ci faccio qui?”.
Digitale, si è detto. C’è un altro manuale che consiglio a chiunque voglia affacciarsi, da ex studente di scienze della comunicazione, a qualsiasi lavoro col digitale. Dico a qualsiasi perché quando l’ho letto ho proprio pensato “ah, se lo avessi letto prima, quante ansie e dubbi in meno”. Parlo di Content Design. Progettare contenuti web che fanno incontrare persone e aziende, lo ha scritto Nicola Bonora per Apogeo e io lo ringrazio. Primo: perché mi ha fornito degli strumenti pratici molto interessanti, secondo, ma forse in verità sarebbe il punto da mettere davanti a tutti, perché anche in questo caso mi ha rassicurato sul mio ruolo, i miei studi, la mia funzione in contesti lavorativi che “hanno a che fare con la comunicazione”. È un manuale che risponde alla perfezione alla domanda “ma che ci faccio qui?”.
Insomma, un fantastico libro che, riassumendo al massimo, spiega perché oggi possiamo parlare di una figura professionale che unisca in sé le capacità del designer e le competenze del creatore di contenuti. “Content design, ovvero, progettazione del contenuto: l’attività di definire la struttura, l’organizzazione e le caratteristiche di un contenuto, o di un sistema di contenuti, che faccia incontrare gli obiettivi di business con i bisogni delle persone”.
Oltre a consigli sul mestiere, su come progettare contenuti tenendo conto di tutta una selva di fattori legati al digitale, all’advertising, ai vincoli del copy ecc, questo libro ha il pregio di rassicurare pagina dopo pagina sul fatto che no, non ci stiamo svendendo se siamo umanisti che si occupano di questa roba, anzi! È proprio il contrario: noi serviamo allo scopo di mettere al servizio mentalità, cultura ed empatia per produrre della comunicazione digitale di qualità. Altro fattore interessante: Bonora mette un po’ di ordine in quella macedonia di titoli, per lo più inglesi, che definisce le professioni legate a contenuti digitali: “in quanto copywriter, content editor, content specialist, o qualsiasi altro titolo che certifichi il nostro essere gente di contenuto, si presume che la nostra natura umanistica ci metta in grado di interpretare questo tutto che è il progetto attraverso una lente grandangolare, che lo inquadri dall’alto nella grande foresta di cui fa parte”. Non (solo) copy, ma architetti di contenuto. Non solo creatori di testi ma progettisti in grado di concepire e allestire percorsi di ricerca su ambienti digitali, e quindi un po’ anche storie.
Ma questa roba si studia? Eccome!
 Il discorso delle storie e della scrittura mi fornisce l’assist per introdurre un manuale evergreen scritto da Luisa Carrada ed edito da Zanichelli: Lavoro, dunque scrivo!. La bibbia, in pratica. Un manuale, ma un manuale vero, concretissimo e altrettanto seriamente utile, che insegna a scrivere bene. Carta o web, non importa: quel che è lucidissimo, in questo libro, è la volontà di scrivere BENE, di conoscere gli strumenti della scrittura e le insidie del testo, di leggere e capire quello che abbiamo sotto gli occhi. Questo non è consigliato, questo è praticamente obbligatorio nella libreria (anzi, sulla scrivania!) di ciascun comunicatore.
Il discorso delle storie e della scrittura mi fornisce l’assist per introdurre un manuale evergreen scritto da Luisa Carrada ed edito da Zanichelli: Lavoro, dunque scrivo!. La bibbia, in pratica. Un manuale, ma un manuale vero, concretissimo e altrettanto seriamente utile, che insegna a scrivere bene. Carta o web, non importa: quel che è lucidissimo, in questo libro, è la volontà di scrivere BENE, di conoscere gli strumenti della scrittura e le insidie del testo, di leggere e capire quello che abbiamo sotto gli occhi. Questo non è consigliato, questo è praticamente obbligatorio nella libreria (anzi, sulla scrivania!) di ciascun comunicatore.
Ora che, con le letture discusse finora, abbiamo individuato problemi, intravisto soluzioni e ci siamo riconciliati con la prima regola, cioè conoscere il testo e affinare gli strumenti con cui lo produrremo per certi scopi, consiglio di studiare. Ancora? Sì, ancora. Specialmente se i testi in oggetto sono manuali nuovi fiammanti che si concentrano su alcuni dei problemi sotto gli occhi di tutti quotidianamente. Per esempio: linguaggio amministrativo – il burocratese senza senso, per capirci, quello che Calvino chiamava antilingua – e linguaggio dei social media.
Da Carocci ho acquistato di recente due volumi molto molto interessanti. Il primo è Il linguaggio amministrativo, di Michele Cortelazzo, che indaga, con tanto di esempi, la tanto sperata modernizzazione del linguaggio della PA in Italia. Il secondo è Comunicazione, dibattito pubblico, social media, di Paola Pietrandrea, che mette le mani dentro il calderone dei social, tra echo chambers, trolls, cercando di mettere insieme frammenti di un discorso pubblico che sembra vaporizzato a favore di discorsi fatti di aria. Il tutto, dal punto di vista di una linguista. Lettura ghiotta e super interessante.
Annamaria Testa: ci vuole un paragrafo solo per lei
 Nel 2020 ho amato, vuoi per il momento storico e personale, vuoi per un’infatuazione senza motivi particolari, Il coltellino svizzero di Annamaria Testa, uscito per Garzanti come raccolta, rivisitata e assestata ad hoc, di svariati pezzi usciti sul web. La magia della Testa è di fare le cose bene (che rarità, ma che bellezza!), per cui questo libro non è un’accozzaglia di cose già viste, ma un percorso di grande senso e profondità. Il riferimento al coltellino – che a me ha finito per ricordare il coltellino Opinel di una celebre analisi semiotica – è la metafora che suggerisce di utilizzare gli spunti del libro per avvitare, stappare, limare concetti e pensieri in funzione di maggiore consapevolezza per agire e muoversi nel mondo digitale, e anche nel mondo là fuori, che sempre più gli somiglia.
Nel 2020 ho amato, vuoi per il momento storico e personale, vuoi per un’infatuazione senza motivi particolari, Il coltellino svizzero di Annamaria Testa, uscito per Garzanti come raccolta, rivisitata e assestata ad hoc, di svariati pezzi usciti sul web. La magia della Testa è di fare le cose bene (che rarità, ma che bellezza!), per cui questo libro non è un’accozzaglia di cose già viste, ma un percorso di grande senso e profondità. Il riferimento al coltellino – che a me ha finito per ricordare il coltellino Opinel di una celebre analisi semiotica – è la metafora che suggerisce di utilizzare gli spunti del libro per avvitare, stappare, limare concetti e pensieri in funzione di maggiore consapevolezza per agire e muoversi nel mondo digitale, e anche nel mondo là fuori, che sempre più gli somiglia.
avete notato che un punto interrogativo a testa in giù somiglia a un amo? Bene: buttatelo nel mare del possibile, e vedrete che qualcosa di interessante ci resterà attaccato
La prima parte del libro è fatta di spunti e riflessioni su alcuni meccanismi-trappola del nostro pensiero, e ha lo scopo di aiutarci a riprendere l’orientamento corretto. La seconda si sofferma su alcuni grandi problemi dell’oggi e cerca di analizzarli con rigore. Con rigore, appunto, ma anche con passione, ragionevolezza, competenza, sembra dirci la Testa, possiamo scendere in campo diversi, forse migliori, in un mondo complesso che a volte ci frega, ci illude, ci sovrasta: con un coltellino svizzero così possiamo salvarci la pelle, mantenere un pensiero libero.
 Postilla del paragrafo su Annamaria Testa, a parte consigliare ogni suo libro, è fare riferimento a una recente riedizione, quella di Le vie del senso, uscito per Garzanti nel 2021. A partire da una frase banale, cioè “bella giornata oggi”, l’autrice fa un viaggione in più di 130 esempi per raccontarci come il senso possa variare variando elementi differenti. Questo libro si avvia da un nucleo semiotico di una certa rilevanza, sia perché proprio un convegno di semiotica ne fece sorgere l’idea, sia perché i temi che affronta non sono poi così distanti da quelli di un corso di semiotica, solo che Testa scrive per mestiere e quindi è coinvolgente e riesce a divulgare mostrando bene concetti chiave che tradotti in parole teoriche sarebbero ostici. Le parole cambiano a seconda di come sono posizionate, di come interpretiamo in base alla nostra enciclopedia o in base a elementi contestuali. Sono uno strumento di lavoro, come ho già ribadito, e sono preziosissime.
Postilla del paragrafo su Annamaria Testa, a parte consigliare ogni suo libro, è fare riferimento a una recente riedizione, quella di Le vie del senso, uscito per Garzanti nel 2021. A partire da una frase banale, cioè “bella giornata oggi”, l’autrice fa un viaggione in più di 130 esempi per raccontarci come il senso possa variare variando elementi differenti. Questo libro si avvia da un nucleo semiotico di una certa rilevanza, sia perché proprio un convegno di semiotica ne fece sorgere l’idea, sia perché i temi che affronta non sono poi così distanti da quelli di un corso di semiotica, solo che Testa scrive per mestiere e quindi è coinvolgente e riesce a divulgare mostrando bene concetti chiave che tradotti in parole teoriche sarebbero ostici. Le parole cambiano a seconda di come sono posizionate, di come interpretiamo in base alla nostra enciclopedia o in base a elementi contestuali. Sono uno strumento di lavoro, come ho già ribadito, e sono preziosissime.
Le basi. Ovvero la semiotica
 Ho usato un termine echiano, poco fa: enciclopedia. Ovvero l’insieme delle nostre conoscenze sul mondo, che Umberto Eco definiva così. Umberto Eco è un autore di cui andrebbe letta l’opera omnia sia che vogliate lavorare in comunicazione sia che abbiate un minimo di interesse verso il mondo, in generale. Perché poi era questa la cosa bella di Eco: la curiosità. Dei tanti suoi volumi di saggistica e teoria semiotica ho amato particolarmente Dire quasi la stessa cosa, il saggio dedicato alla traduzione. Con la consueta ironia mista a una visione sempre allargata sui fatti, Eco ci porta alla scoperta dei salti di senso che la traduzione sottende, delle sue insidie, ma anche divertimenti, insomma dei suoi giochi, nel senso etimologico di spazio di gioco, spazio in cui si può fare qualcosa fuori dal meccanismo previsto. Un libro gustosissimo, che vi rimette al centro del mondo corazzati di consapevolezza sul linguaggio. E attraverso questa carrellata di libri si è notato come sia una competenza fondamentale per lavorare oggi in comunicazione – o forse anche solo per vivere meglio in un universo caotico.
Ho usato un termine echiano, poco fa: enciclopedia. Ovvero l’insieme delle nostre conoscenze sul mondo, che Umberto Eco definiva così. Umberto Eco è un autore di cui andrebbe letta l’opera omnia sia che vogliate lavorare in comunicazione sia che abbiate un minimo di interesse verso il mondo, in generale. Perché poi era questa la cosa bella di Eco: la curiosità. Dei tanti suoi volumi di saggistica e teoria semiotica ho amato particolarmente Dire quasi la stessa cosa, il saggio dedicato alla traduzione. Con la consueta ironia mista a una visione sempre allargata sui fatti, Eco ci porta alla scoperta dei salti di senso che la traduzione sottende, delle sue insidie, ma anche divertimenti, insomma dei suoi giochi, nel senso etimologico di spazio di gioco, spazio in cui si può fare qualcosa fuori dal meccanismo previsto. Un libro gustosissimo, che vi rimette al centro del mondo corazzati di consapevolezza sul linguaggio. E attraverso questa carrellata di libri si è notato come sia una competenza fondamentale per lavorare oggi in comunicazione – o forse anche solo per vivere meglio in un universo caotico.
Non posso quindi non citare un volume recente, uscito nel 2021 per la collana Campo Aperto che lo stesso Bartezzaghi dirige. Mettere al mondo il mondo, oltre ad avere un titolo bellissimo, è il più recente studio di Stefano Bartezzaghi su un tema che gli è caro e che aveva già affrontato in L’elmo di Don Chisciotte. Contro la mitologia della creatività (Laterza) e Il falò delle novità (Giunti). Il primo titolo dà una chiara indicazione: parliamo di creatività, ma non di che cos’è, bensì del discorso – dei discorsi – che l’accompagnano, e che la rendono una mitologia. Questo volume di Bartezzaghi, va detto, contiene molta semiotica, e dallo sguardo semiotico, dal metodo, trae il ragionamento che lo accompagna per cercare di capire come mai l’uomo senta il bisogno di parlare di creatività per riferirsi a qualcosa che in realtà gli serve per dire cose di sé. La creatività, di fatto, non esiste, e Bartezzaghi ci spiega come, al contrario, è una costruzione di senso dentro al mondo fluido e cangiante dei discorsi sociali.
Lo fa da studioso, partendo da una definizione dizionariale e ponendosi degli interrogativi. Tutti, infatti, sembriamo essere a nostro agio davanti al termine creatività, ma messi alle strette non riusciamo a individuare chiaramente una definizione, ci sfugge il significato di un termine davvero vago. Da qui, la semiotica della creatività che Bartezzaghi allestisce cercando di dare conto delle connotazioni, degli usi mediatici della parola. Lo fa costruendo una tipologia a forma di piramide, che parte dalla creatività sacra del discorso artistico e arriva a quella conoscitiva, quella produttiva, quella mediale, pubblicitaria e quella quotidiana, dove il falò della creatività finisce per spegnersi.
Parola d’ordine: consapevolezza
Ecco così dimostrato come una delle parole prezzemoline più sentite negli ultimi tempi sia in realtà un mero costrutto discorsivo che ci dice molto, molto altro. La bellezza di quest’analisi semiotica, secondo me, sta tutta nel suo rigore, e nel fatto che ci parla di fenomeni sotto i nostri occhi tutti i giorni. Con lo stesso rigore dell’analisi sulla creatività, Bartezzaghi sfata un altro mito moderno, quello di storytelling, concetto e parola altrettanto vaga. Mettere al mondo il mondo è un libro da studiare e da gustare già solo per queste attentissime analisi che smontano con raffinati ragionamenti nuvole di vapore che ogni giorno ci offuscano la vista impedendoci di mettere a punto, cum grano salis, tutti quegli strumenti di cui parlavano i manuali fin qui citati. E poi, va sottolineato che nella terza parte, che segue l’analisi della creatività come schema narrativo (altra metodologia semiotica), Bartezzaghi non resiste a citare uno dei temi che intriga entrambi da sempre: l’Oulipo, le contraintes e quel pazzesco laboratorio che ne è venuto fuori.
Mi rendo conto che questa galleria di scritti sulla comunicazione sia qualcosa di estremamente variegato e racchiuda testi dall’anima diversissima. Ma, oltre a essere una proposta meramente soggettiva, è un insieme di testi al cui centro ho voluto mettere la consapevolezza. Quella di stare lavorando con uno strumento che, come tale, va affinato. Quella di poggiarsi su un piano elastico, ancora non normato e da istituzionalizzare. Quella di avere a che fare con la materia del senso, che spesso ci inganna e come un boomerang finisce per tornarci sui denti se non stiamo attenti a gestirla. Quella dell’uso di parole che sono in realtà vuote e sottendono mondi, visioni del mondo, racconti che ci portano lontano, mentre lungo il viaggio scopriamo cose nuove e impariamo, sveliamo, ci accorgiamo.
“Di fatto, solo vedendo, guardando e osservando noi possiamo stabilire il nostro posto nel mondo che ci circonda. Chi non sa vedere non può nemmeno costruire visioni – dice Annamaria Testa – E, per poter guardare oltre, bisogna prima imparare a vedere, guardare, osservare quel che abbiamo qui, adesso, magari proprio davanti al nostro naso”. Un invito su tutti a non smettere di aggiornarsi, leggere, essere curiosi di capire i meccanismi che governano questo grande calderone pazzesco che chiamiamo comunicazione.