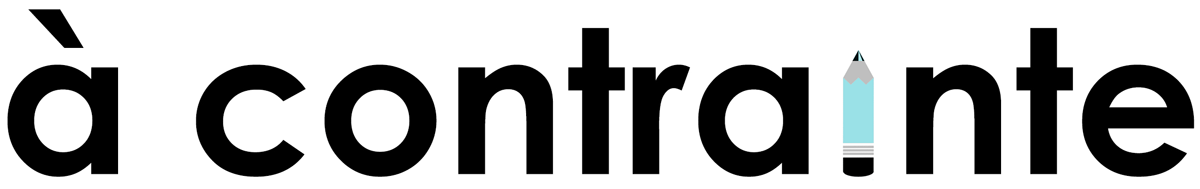Chi si occupa di guide letterarie lo sa: la materia, ammesso la si possa chiamare tale, ogni tanto scivola di mano, è difficilmente addomesticabile. Perché che cos’è una guida letteraria, esattamente? Una guida ai luoghi narrati dagli scrittori, una guida agli scrittori, attraverso descrizioni di mondo che hanno scritto, una miscela delle due cose? Una risposta definitiva non c’è: quello dei paesaggi e delle città di carta è un territorio cangiante, e forse è bello proprio per questo. Dunque in questo mondo indefinito si colloca, a suo modo, anche “L’Italia di carta” (Il Saggiatore), il recente libro di Antonio Canu, che è un ambientalista, un giornalista ed è stato responsabile nazionale delle Oasi Wwf.
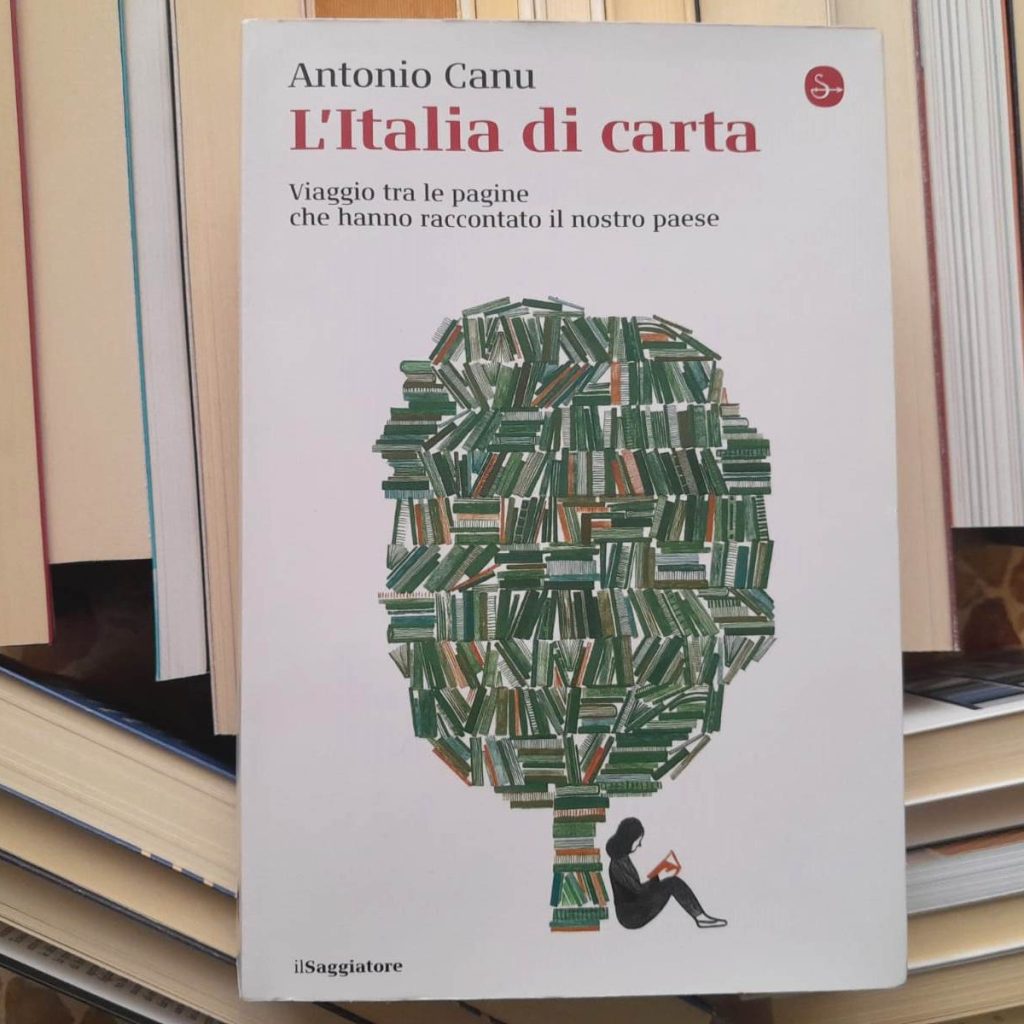
Il punto di vista del naturalista
Il profilo biografico dell’autore aiuta meglio a inquadrare questo libro che, tutto sommato, forse una guida letteraria non è. Non lo è perché il progetto, che pure si nutre di tantissima letteratura, è incentrato su una visione prettamente naturalistica. È un viaggio molto particolare: parte dalla Sardegna e approda in Sicilia, passando per tutta la penisola, abbracciando l’arco alpino dal Piemonte al Veneto, planando sul Po, grande via d’acqua del Paese, e scivolando a sud sul dorso degli Appennini, fino al Pollino. Canu disegna un itinerario fatto di geografia e pagine letterarie insieme, perché sceglie di descrivere alcuni territori, o meglio alcuni paesaggi.
Ora, sulla nozione di paesaggio non basterebbe un’intera bibliografia per riuscire ad affermare qualcosa, Canu lo sa e lo anticipa nell’introduzione. Parlare di paesaggio significa, tra queste pagine “di carta”, raccontare i luoghi come ambienti naturali, ma anche come territori segnati dalla presenza dell’uomo, nel bene e nel male (e spesso, ahinoi, il male è perdita di biodiversità e mancanza di rispetto), e come scorci che qualcuno ha fatto propri attraverso l’inchiostro della letteratura, ma non solo.
In questo percorso non compaiono solo narratori, ci sono storici e geografi, persino dell’età antica (Strabone o Plinio il Vecchio), c’è Dante, che forse nella definizione di “narratore” si sentirebbe un po’ stretto, ci sono autori che erano anche giornalisti, c’è lo sguardo ispirato di chi ha ambientato storie in certi luoghi, ma anche l’occhio di chi quei posti li ha scelti per trascorrere del tempo, e c’è l’io dell’autore, che ogni tanto commenta, aggiungendo emotività o commenti che riguardano per lo più la spiccata sensibilità ambientale di questo libro. Aspetto, questo, che non lo renderà una guida letteraria, ma lo rende invece un’interessantissima e particolare guida ai paesaggi d’Italia e alla loro interazione con l’elemento umano, anche grazie all’aiuto della lettura che ne danno gli scrittori.
Il paesaggio culturale
In “L’Italia di carta” c’è molta geografia, c’è quindi anche molta presenza umana nei luoghi. C’è, secondo me, il paesaggio culturale (altra definizione, con paesaggio, che porterebbe via bibliografie intere), quello che l’uomo ha determinato nell’intreccio di natura e presenza, quello che gli scrittori hanno incontrato e raccontato. In un viaggio fatto di natura e cultura, di visioni che nascono proprio da questa sovrapposizione, al centro non può che esserci l’uomo. Canu aggiunge al suo percorso anche una scala diacronica, spostandosi sull’asse temporale dall’età latina a oggi, citando fonti antiche e autori contemporanei. È necessario: i luoghi cambiano nel tempo sotto l’influenza umana, e per vederli, e capirli, è necessario andare alle radici storiche, a volte a quelle antichissime, geologiche, che hanno modellato i paesaggi e determinato la vita dell’uomo in specifici territori. Luoghi belli, di grande ispirazione per gli scrittori, ma anche luoghi che sarebbero stati in ogni caso interessanti dal punto di vista naturalistico, e che sono cambiati nel tempo, ecco che cosa ci racconta questo viaggio attraverso visioni e interpretazioni.
Tutti i paesaggi che incontriamo tra le pagine sono porzioni di territorio con una singolare identità, magari frutto di contaminazioni, di incontri o scontri con l’uomo. Ma un paesaggio è anche fatto di carta, forse, e questo dato certo affascinante si specchia nell’insieme mai troppo definito di identità geografica di un luogo e di interpretazione dell’uomo che quel luogo lo guarda e lo vive: necessariamente soggettiva, ricca di emotività.
Paesaggi come libri da sfogliare
Qualunque sia l’oggetto di indagine, di capitolo in capitolo in questa “Italia di carta” si scoprono i mille volti e le micche ricchezze d’Italia e viene voglia di viaggiare, ma anche di leggere, che forse è un po’ viaggiare da fermi tra le pagine, oppure viaggiare al quadrato, sommando alle percezioni dei nostri occhi le interpretazioni e le letture che la mente ci consente, aggiungendo punti di vista. Gli accompagnatori sono tantissimi – e la bibliografia ne dà testimonianza – ci sono autori che i territori li hanno vissuti a lungo, conoscendoli e imparando a farlo, autori che sono passati di lì e sono rimasti colpiti da qualche aspetto.
Qualche flash, per ingolosire: c’è Virginia Woolf tra le pagine di un diario italiano sulla campagna romana, la Maremma attraversata dal nastro dell’Aurelia in un ventaglio di approcci autoriali (e sì, c’è anche Italo Calvino con la Pineta di Roccamare), le Dolomiti che tanto affascinavano Buzzati. Ci sono dei ciceroni d’eccezione come Guido Piovene (è lui a dire che l’Italia è un distillato del mondo, con tutti i suoi paesaggi) e Corrado Alvaro con i loro reportage sull’Italia. E poi c’è Annibale che scavalca le Alpi con gli elefanti (ma sarà poi vero?), gli inconfondibili profili del Monviso e delle Dolomiti, e l’Appenino segreto, i monti Sibillini con il loro mistero, e quelli della Marsica, con i parchi naturali pieni di biodiversità, ma anche di leggende. Le hanno raccontate gli storici latini quando la penisola, a conti fatti, era ancora lungi dal diventare Italia, e così Dante qualche secolo dopo.
Non potrebbe mancare il mega-microcosmo del Delta del Po, con la sua storia geografica antichissima. E proprio il delta suggerisce all’autore una definizione che secondo me è applicabile a tutti i paesaggi toccati, a tutti i “capitoli” dell’Italia di carta: un “insieme di ambienti, storia, cultura, quel paesaggio disegnato e ridisegnato nel tempo, molte volte offeso se non peggio dalla mano dell’uomo, quel serbatoio immenso di biodiversità”. Tutto questo si trova tra le pagine del corposo volume di Canu: viaggi reali, viaggi fatti di parole, viaggi che si arricchiscono allargandosi nel tempo e nello spazio, disegnando un’Italia bellissima che viene voglia di scoprire e riscoprire spostando continiamente gli occhi, come faceva Quinto Anfossi, il protagonista di “La speculazione edilizia” di Italo Calvino, dal libro al paesaggio fuori dal finestrino del treno.