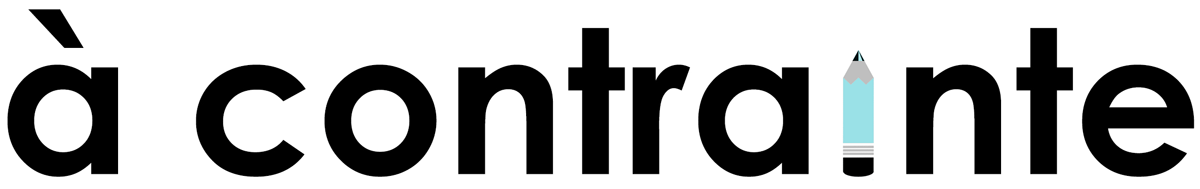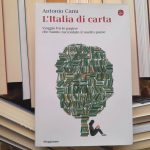“Solo dopo aver conosciuto la superficie delle cose – conclude il signor Palomar –, ci si può spingere a cercare quel che c’è sotto. Ma la superficie delle cose è inesauribile”. Celeberrima, questa citazione da Palomar di Italo Calvino. Ecco perché lo studio di Niccolò Scaffai “Sotto l’inesauribile superficie delle cose”, pubblicato da Aboca, mi ha incuriosita molto. Questo libro è un’analisi estremamente limpida e molto affascinante sulla contrapposizione superficie- profondità. Dentro ci sono un sacco di riferimenti letterari, dei quali ça va sans dire Calvino è il filo conduttore, ma soprattutto, dentro si incastrano architetture assiologiche che, a partire dalla suggestione spaziale e volumetrica di superficie e di profondità, danno conto dell’architettura di un certo pensiero contemporaneo. Un pensiero che ha a che fare con la rappresentazione in letteratura di ciò che vive il nostro mondo di oggi, dei suoi problemi, delle sue crisi, dei suoi interrogativi universali che a volte, come eruzioni vulcaniche, ci ricordano la loro necessità, la loro origine.
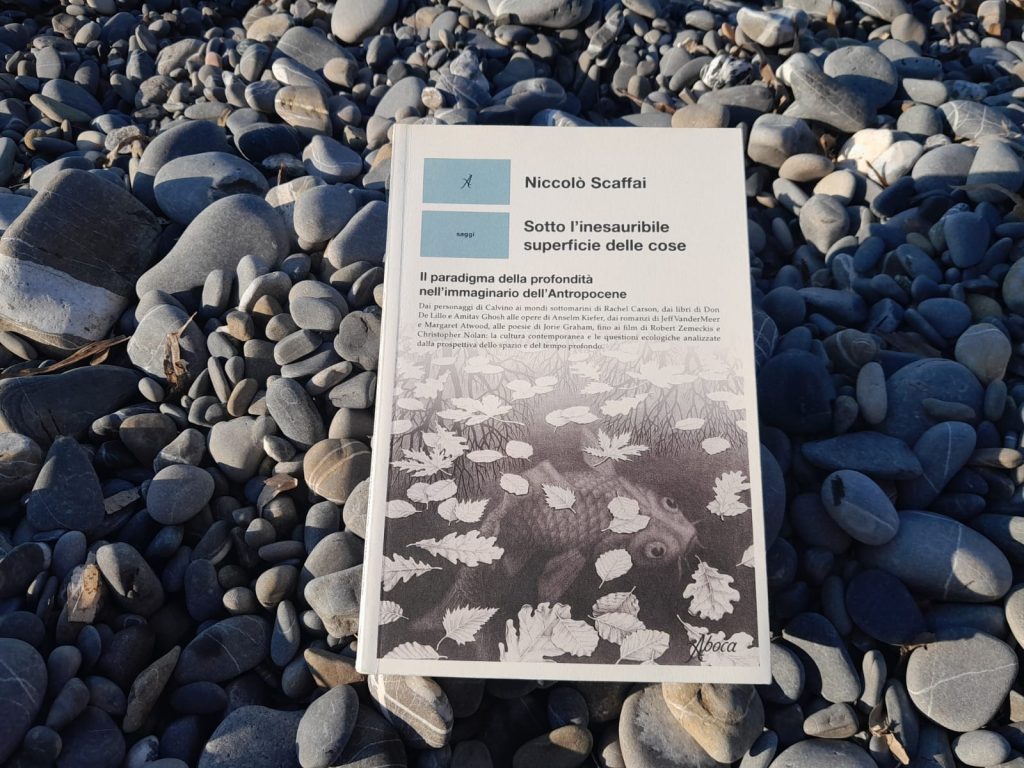
Lezioni sulla profondità
La ricerca di Scaffai parte dal presupposto che la profondità è un tema ricorrente nell’immaginario contemporaneo, e se è vero che è un archetipo da sempre usato in letteratura, l’operazione che fa lui in “Sotto l’inesauribile superficie delle cose”è di legarlo all’oggi dell’antropocene, la nostra firma sul pianeta. Profondità e crisi ambientale si implicano a vicenda attraverso i cardini del testo, le sue strutture, cioè spazio e tempo. Pregio di queste che potremmo definire “lezioni sulla profondità”, guidate dall’ispirazione calviniana che, da ben molti anni prima di questa crisi, guida le intuizioni, è vedere – sì, proprio vedere – collegamenti e implicazioni decisivi per riformulare la propria idea di mondo. Come la considerazione per cui noi, oggi, a discapito della superficie imperante, dipendiamo dalla profondità: il petrolio.
È una contraddizione – del resto anche Calvino amava le contraddizioni – e come tale genera un momento di stop, una riflessione successiva. La letteratura accompagna, oggi, in questa riflessione. Secondo Scaffai lo fa rielaborando le idee sui tempi e gli spazi e dando quindi una nuova interpretazione alla profondità, costruendole un nuovo immaginario. Le lezioni conducono tutte qui: il tema della crisi ecologica e la tensione della letteratura nel rappresentare la realtà che viviamo si intrecciano proprio nella dimensione della profondità.
Gli esempi portati dall’autore sono numerosi, viene davvero voglia di approfondire e leggere un sacco di libri sezione dopo sezione. Sono sei quelle portate in evidenza nel libro, dagli emblematici titoli: guardare, nascondersi, terra e fuoco, paesaggi contaminati, il mare, il tempo profondo. Profondità è infatti scavare in una metaforica colonna che va sotto terra, ma anche sotto la superficie (appunto!) del mare, aprendoci a un mondo che ancora non conosciamo, ma che sostiene tutto il resto.
Imparare da Palomar
All’inizio del libro c’è un invito, quello a guardare in profondità. Chi, se non Palomar, è l’emblema perfetto per rappresentare lo scacco della superficie inesauribile, che impedisce proprio di accedere alla profondità? Palomar guarda il mare cercando di catturare una singola onda, ma non ci riesce mai: la superficie del mare sembra infinita, come accedere a tutto quello che c’è sotto? Grande dispositivo ottico in forma di personaggio (qualora mi leggesse ringrazio l’autore del libro perché questa suggestione mi è stata utile per parlare di Palomar dentro un planetario, in fondo anch’esso dispositivo ottico che implica una riformulazione di spazi e tempi tale da permettere l’accesso alla profondità), Palomar non riesce a cogliere – anche se vorrebbe – la complessità.
A riempire questo vuoto nella ricerca, Calvino aveva immaginato un altro personaggio, nettamente opposto a Palomar, ovvero il signor Mohole, il cui nome si rifa’ a un progetto di trivellazione, spunto che già lo colloca proprio in profondità, nello scavo della terra. Il progetto poi non prese forma, e del signor Mohole non abbiamo resti, se non in un sorta di “altra metà” di Palomar: se infatti solo dopo aver esplorato la superficie si può andare sotto, allora nell’intento – benché mai realizzato – di Palomar c’è già anche Mohole: ci sono la luce e l’oscurità. E, aggiungo io, ci sono dunque i binomi calviniani tipici, come l’aprico e l’opaco che tutto definiscono a partire dal paesaggio.
Ma non usciamo di pista. I riferimenti a Calvino si susseguono. Ecco le “Cosmicomiche” citate con un racconto sui dinosauri che ben restituisce la capacità visionaria di Calvino di dilatare tempo e spazio rendendoli ultra-umani. Qfwfq ha questo pregio molto moderno: sposta le categorie, guarda oltre, vede sistemicamente, con la dovuta ironia. Questo sguardo speciale era proprio di Calvino: ecco “Le città invisibili”, visionarietà pagina dopo pagina, ma ecco anche tanti racconti che hanno una profonda radice ecologica, consapevole o meno visto che l’ecocritica ai tempi di Calvino ancora doveva prendere forma. C’è “La pompa di benzina” in “Prima che tu dica pronto”, dove si tematizza l’esaurimento delle risorse (ah, ma quindi già si sapeva), e c’è anche “La pubelle agrée”, che si immerge nel mondo dei rifiuti. Più contemporaneo di così. Calvino in questo libro di Scaffai è centrale, è uno spunto, una visione, una voce attraverso cui rileggere il mondo. Viene nostalgia a pensare “che cosa avrebbe mai detto, lui, oggi?”.
Dando un perché all’angoscia ecologica
Ho letto “Sotto l’inesauribile superficie delle cose” durante la prima ondata di calore dell’estate 2025, tra giugno e luglio, e ho trovato tempo di scriverne solo ora, durante la seconda letale ondata di calore. Segni di qualcosa che cambia, un allarme ormai esasperato, un senso di paura strisciante, anzi di angoscia. La conclusione di questo testo è stata una chiave utile per accompagnarmi in un cambio di prospettiva durante questa crisi vissuta sulla pelle. Non ci sono segreti, mostri o meraviglie nella profondità: solo una maggiore conoscenza, e soprattutto quella dilatazione di tempo e spazio che scalza l’antropocentrismo che ci acceca, permettendoci di vedere tutto molto meglio.
In altre parole: questo testo rivela in maniera superba, attraverso i libri e il ribaltamento assiologico rintracciato nell’immaginario letterario, che i rapporti su cui si basa il nostro modo di vivere sono insostenibili. Da un lato spiega la complessità della crisi ecologica che viviamo, dall’altro accompagna alla riflessione sulla crisi la spiegazione di un pensiero ecologico, e lo fa consigliando un sacco di libri e riportando al centro Calvino, luminosissimo in tutta la sua modernità. La prospettiva straniante di Qfwfq, la sua dimensione nuova e inaspettata, aiuta a capire meglio che cosa sta succedendo, quali sono i rapporti di forza e i valori in gioco.
Per l’autore la profondità non è solo un tema ma un modello di comprensione, valido per la scienza come per la letteratura, che “ce lo fa vedere”. I racconti analizzati, e i libri, non sono mai di fantascienza, ma basati su un realismo che accompagna verso la profondità. È questa, per Scaffai, una delle vie di accesso privilegiate per il pensiero ecologico. Indagare la profondità consente di indagare le dinamiche – estese, oltre all’umano – che governano il mondo e determinano le nostre condizioni. Anche quelle che riguardano il caldo angosciante e anomalo di questi periodi.
Ancora Calvino
Ebbene sì, perché se Scaffai pone questo suo metodo come paradigma conoscitivo dinnanzi alla crisi che viviamo, si tratta di un problema di conoscenza, e quindi di un problema che avrebbe interessato anche Calvino. Oggi, forse, avrebbe prevalso l’impulso a guardare in basso di Mohole, concentrato non su come rappresentare un mondo cosmico fatto di nuovi orizzonti, ma su come salvare questa terra che ci ospita. Calvino ce lo diceva già in tempi non sospetti, ma la letteratura di taglio ecologico oggi lo grida forte: guardiamo in profondità, perché solo lì potremo capire le implicazioni alla radice della nostra crisi, nelle relazioni ecologiche. In poche parole, la letteratura che guarda alla profondità ci spinge verso il pensiero ecologico, dentro le ferite del pianeta, dentro la crisi che ci investe, bolliti di caldo, formiche sulla superficie di un mondo che grida un disagio adattandosi, e che se continuiamo così, a modificarlo, non farà altro che scrollarcisi di dosso.
La comprensione di una realtà così complessa come quella che stiamo vivendo richiede capacità di visione nuove: prospettive ampie, profonde, appunto, spesso non comuni. Secondo Scaffai il racconto degli ambienti profondi ci accompagnerà verso un nuovo pensiero: una geografia naturale, ma anche sociale, che abitiamo e dalla quale oggi siamo interrogati.
Ed è così che mentre leggevo, avevo caldo, un caldo torrido, e trovavo splendidi riferimenti all’attualità di Calvino, intercettavo anche un messaggio ecologico alla base di tanti lavori che faccio con i biologi marini. Portare la bellezza e ricchezza del mare in superficie per farla vedere a tutti, raccontare cosa c’è sotto per capire il sopra, i suoi meccanismi, i suoi problemi. Se la Posidonia oceanica è una pianta che, con le altre piante marine e alghe, ci regala la metà dei respiri che facciamo ogni giorno, forse è importante, forse bisogna salvarla. Se Calvino aveva esteso il suo sguardo oltre le consuetudini già 60 anni fa, forse bisognerebbe rileggerlo. Insomma, un libro fondamentale “Sotto l’inesauribile superficie delle cose”, una delle letture più arricchenti degli ultimi mesi, ne deriveranno altri numerosissimi libri da scoprire.