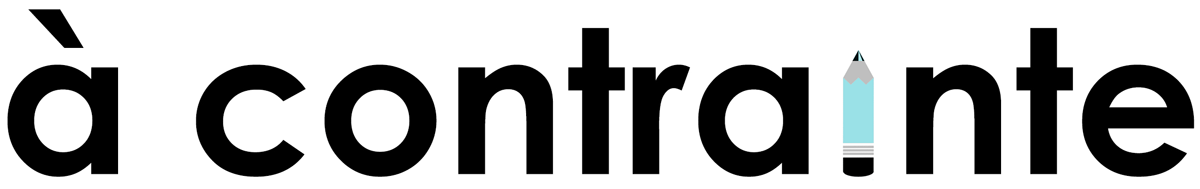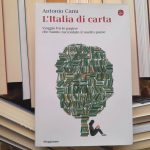Martin McLaughlin si è spento lo scorso gennaio. Proprio poco, pochissimo prima che uscisse per la collana del Laboratorio Calvino di Carocci il suo volume, “Calvino e la letteratura mondiale”, che approfondisce la narrativa, la saggistica e soprattutto il tema dell’intertestualità in Calvino. Attendevo da tempo questo libro, non solo perché McLaughlin, già professore emerito di Italiano a Oxford, è stato uno dei traduttori di Calvino in inglese, e uno dei critici “storici”, che più spesso ho incontrato nelle bibliografie. Ed ecco il secondo motivo per cui lo aspettavo: perché è la traduzione in italiano, ampliata e aggiornata, di un volume che avrei tanto voluto leggere per i miei studi ma che esisteva solo in inglese, ed era introvabile, un volume considerato una pietra miliare della critica calviniana. Con i tempi lenti che fanno sì che questo volume arrivi nelle mie mani quando il suo autore non è più su questo pianeta, eccoci dunque finalmente al testo. La fortuna, piccolina, è stata quella di incontrare McLaughlin a poca distanza da casa, durante il convegno del 2022 che Sanremo ospitò preparando il centenario. Il professore fece un discorso multilivello sulla spazialità, o meglio sugli spazi, nella narrativa di Calvino, e mi colpì perché più di qualsiasi altro intervento aveva a che fare con la mia tesi di dottorato, e spiegava con una chiarezza e una semplicità a volte estranee al mondo accademico il suo pensiero.
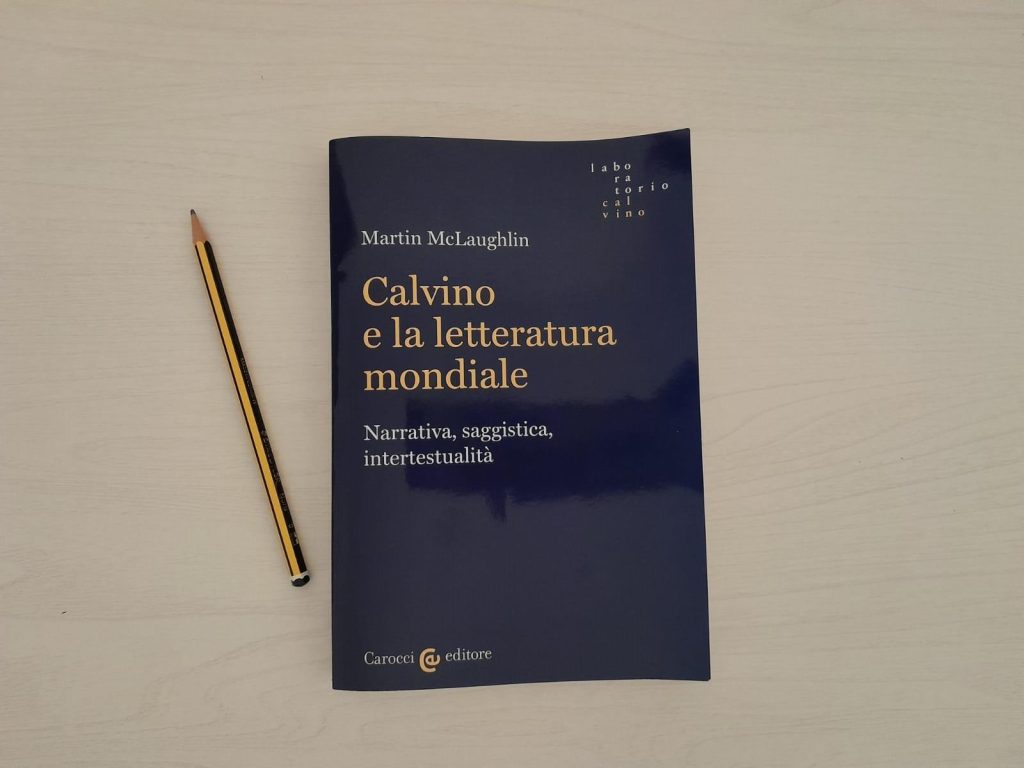
Un ricchissimo viaggio dentro al testo
Questo libro è un saggio approfondito, un’avventura nella narrativa di Calvino la cui lettura mi è sembrata, proprio come accadeva ai testi di Calvino stesso, frutto di una contraddizione che riesce a stare insieme. Da una parte infatti il testo è così lineare e chiaro, nel suo percorso fondamentalmente cronologico sulle opere calviniane, che mi è parso perfetto per chi voglia approcciare per la prima volta l’universo cangiante della narrativa di Calvino. C’è dentro, passo passo, tutta la produzione, specialmente la narrativa, dai primi racconti fino a Palomar. È un itinerario prettamente poetico: da buon professore di italianistica McLaughlin resta dentro al testo, e di quello ci parla. Delle sue interpretazioni, delle sue relazioni con l’opera omnia di Calvino, dell’evoluzione del pensiero, dell’approccio, e naturalmente delle influenze con il panorama letterario circostante.
Dall’altra parte, è un testo che a ogni pagina offre un approfondimento dal punto di vista speciale del traduttore, che è forse colui che meglio di altri può e deve leggere un testo. Dico così perché la lente sotto la quale McLaughlin sceglie di leggere Calvino è quella dell’intertestualità, ovvero delle influenze, più o meno esplicite, più o meno storicamente sottolineate dalla critica, del pantheon di autori che sono entrati nelle pagine del nostro autore del cuore. La produzione di Calvino è densissima di strati intertestuali, c’è da perdercisi dentro. E il professore di Oxford riesce a tirare fuori molte interessanti notazioni che a una prima superficiale lettura non apparirebbero, ma che ora, che nella mia bibliografia calviniana ci sono un bel po’ di pagine, sembrano illuminare nuovi spunti e percorsi.
È vero: questo testo era imprescindibile nello studio e nell’approccio a Italo Calvino e alla sua narrativa. È lì che si concentra l’autore, con un’analisi rigorosissima dell’evoluzione delle opere di Calvino decennio dopo decennio, con interpretazioni che mi sono suonate nuove e curiose, come per esempio una lettura che tiene insieme opere del primo periodo in termini di amore e impegno politico. E poi, c’è la ricostruzione. La genesi e la storia filologica dei testi di Calvino è complessa: sono stati ri-composti, rimaneggiati per esigenze editoriali, l’autore stesso li ha forgiati come meglio credeva avrebbero potuto trasmettere un’immagine di sé che cambiava nel tempo. Spesso ricostruire questi passaggi è complesso, invece McLaughlin riesce, con molta pazienza ed estrema precisione bibliografica, a dare conto di tutti i passaggi, con le relative ricadute che hanno sul pensiero e la poetica di Calvino. Nulla è casuale in questo autore, ormai lo sappiamo.
Con sguardo calviniano
L’approccio e lo sguardo che si posa su Calvino da parte del professore inglese ha probabilmente influito su questo testo, che ci arriva frutto di un lavoro critico datato (il volume originale in inglese risaliva a metà degli anni Novanta), ma che è acuto e, lo ripeto, imprescindibile per gli studi calviniani. Lo è perché McLaughlin si dedica con perizia a esplorare la complessissima genesi delle opere di narrativa di Calvino, cioè racconti, e relative raccolte, a volte modificate nel tempo più volte, e romanzi, dall’esordio fino alle opere più sperimentali. Di ogni opera fornisce una sorta di summa, commentando criticamente l’approdo di Calvino a determinate scelte, e soprattutto inserendo quel lavoro nella rete affollata dell’intertesto.
Non ci sono infatti solo rimandi agli autori che Calvino aveva letto e amava, e che ha citato quasi sempre nelle Lezioni Americane, consegnandoci la cosa più vicina alla sua idea di letteratura. Accanto a notazioni specifiche che vanno dalla tesi su Conrad, che io stessa ho potuto sfogliare all’archivio storico dell’Università di Torino (dove, immagino, sia stato anche McLaughlin, vista la precisione dei suoi riferimenti) fino a Borges, passando per un ventaglio straordinario di riferimenti che abbracciano sì i testi di Calvino, ma soprattutto il suo intero pensiero, la sua poetica, appunto, c’è anche un approfondito rimando, con spunti molto utili, sull’intertesto dentro i testi calviniani stessi.
Calvino si citava? Sì, più o meno: Calvino faceva riferimento alla propria opera, e in forma probabilmente inconscia, tornando cioè su temi che facevano parte del suo pensiero, e in forma consapevole, parte di raffinatissimi meccanismi metaletterari che da un certo punto in avanti ha iniziato a creare sulla pagina scritta. C’è quindi, oltre ai tantissimi autori stranieri cui McLaughlin rivolge la sua ricerca – e di questa specificità fa parte l’ultimo capitolo dedicato in particolare all’influenza della letteratura anglofona su Italo – un’attenzione costante alla rete testuale interna. È questo sguardo costante, di assoluto controllo su quanto prodotto da Calvino, con una fitta bibliografia critica, a restituire la classicità del saggio di McLaughlin e a farne una colonna per chi volesse avvicinarsi a uno studio attento della poetica calviniana. Qui troverà tutto ciò che occorre per iniziare il viaggio. Il bagaglio è estremamente ricco: al controllo assoluto di Calvino, che rimaneggiava le sue raccolte di racconti – e qui si spiega il perché e il come – si aggiunge la sempre elegante e profonda attenzione di un docente che, ne sono certa dopo averlo sentito parlare in ottimo italiano, e dopo averlo letto, ha costruito pagine davvero importanti per la critica calviniana.