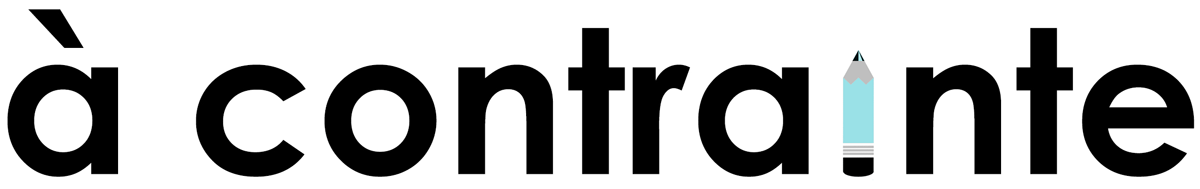Oggi sono uscita a camminare, e ho pensato che scrivere, riprendere i fili delle cose che penso, collego e che capitano in questa piega della storia che resterà come un segnalibro amaro, mi mancava. Così ho sfruttato la simbolica data di oggi, 18 maggio, una fase due bis, che segna il tempo sospeso che va dal 4 maggio, quello famoso, del primo liberi tutti – o quasi – a oggi, che tutti leggiamo come ripartenza, anche se è piena di ma.
Ci sono stati due episodi nitidi che come nessun’altro ragionamento o commento di telegiornale mi hanno fatto toccare con mano cosa significhi convivere con il virus. Dicono tutti così: che non tornerà come prima, che fino al vaccino dovremmo conviverci, con il virus. Muoverci, certo, riaprire tutto, circa, ma stare attenti, in guardia. Mascherine, guanti, alcol, massima allerta. Liberi e costretti insieme. Una contrainte. È che in questo caso spaventa, e spaventa perché mentre io indosso tuta e scarpe da ginnastica e scendo giù nell’aria di maggio, che proprio oggi è una bolla calda di phon, scirocco in risalita, un’ambulanza sfreccia su Capo Berta passandomi sui piedi mentre sono sulle strisce pedonali che attendo di passare. Una ragazza che andava a correre mi ha appena superato, i capelli in una coda svolazzante, il cellulare nella fascia al braccio. Ho pensato che bello, la primavera inoltrata e la gente libera, la vita riprende. Due secondi dopo, neanche fossi caduta in un mondo sottosopra, l’ambulanza con i medici in tuta bianca di biocontenimento al volante. Lì ho davvero pensato che questa era la fase di convivenza, chiamiamola fase due, che fosse quella dal 4 maggio a oggi, che fosse quella di oggi.
Oggi ha ripreso tutto, a cominiciare dal traffico, aumentato percettibilmente anche sotto casa, che è un posto defilato, era una bolla di silenzio, rane e cinguettii nell’aprile che tutti ricorderemo e di cui qualcuno, io ci sono nel mezzo, sentirà la mancanza. Una struggente bellezza. Malinconica, di bellezza che poteva essere ma era solo un caso, un momento, un passaggio. Oggi è già finita, anche se siamo nella fase due, quella della convivenza. Il traffico sommerge i pensieri, quella calma che dettava il nuovo ritmo alle giornate. Perché che sia tutto nuovo, qui, è ben chiaro. A partire da chi scrive, da come lo fa, da dove, da quando. Giornate che si srotolano con scarsi orizzonti, improvvisamente è tutto così ristretto, così confortevole e insieme spaventoso. La ferita inizia a sentirsi, deve ancora emergere, come tutte le cose traumatiche. Serve del tempo, ma sotto c’è qualcosa che si è frantumato: sono in allerta, controllo.
Dal 4 maggio a oggi sono passate due settimane, la primavera si è fatta intensa, c’è stata una libecciata, il mare come spuma e gli occhiali pieni di salsedine, la meraviglia nel profilo della città sfumato dentro la nube di vapore dell’acqua, una silhouette nella bolla dorata. C’è stata la pioggia, le rose, le consegne a casa per date importanti, gli appuntamenti saltati, quelli concordati e vabbè. C’è stata una settimana per capire e tentare, una per lavorare sodo, una sola meta, finalmente un obiettivo, sfiancante ma entusiasmante. C’è stato il nervosismo, come sempre ha rovinato tutto. E poi è arrivato un caldo appiccicoso, un phon sparato addosso nel lunedì in cui tutto riapre, arrivano amici sotto casa, piante in terrazza, la felpa è di troppo, gli occhi bruciano.
Scendo a camminare sul mare ed ecco un’altra stilettata che faccio fatica a combattere, la seconda di quelle immagini che definiscono chiaramente nella mia testa la fase due. Faccio per attraversare, sempre sul Berta, e non posso: c’è un’ambulanza ferma, lato strada, proprio davanti alla scala che dovrei fare. Ci sono due operatori in tuta, sono lì, chiudono il portellone. Non so cosa fare e le gambe rispondono per me lanciandosi in mezzo alla strada ben prima dell’attraversamento. Giro alla larga, non posso fare a meno di guardare: chissà se mi hanno visto. Brividi, pugno nello stomaco. Corro, devo correre via da lì, io con la tuta felice di uscire di casa, qualcuno che sta male e ha addosso un virus per il quale non esiste vaccino. Stride da stordire i pensieri, unghie sulla lavagna, senso di irrealtà galoppante. Me ne voglio dimenticare.
E allora cammino, con le cuffiette, cammino e schivo la gente, perché oggi c’è pieno e fa caldo, l’odore di mare è forte, estivo. Di fatto, oggi sembra estate, e le spiagge lisce lo confermano. C’è tantissima gente, tantissimo traffico. Ho nostalgia delle serate deserte di una primavera che aveva tutto da promettere, di noi pochi camminatori e sportivi serali, padroni del mare che sarebbe arrivato a riempire un’altra estate, quella della pandemia. Eccola, è già qui, è arrivata senza che me ne rendessi conto. È la prima volta che quando arriva l’estate sono già a casa: non capitava da anni. Scorre tutto: gli appuntamenti, i festival, i concerti andati, il Salone del libro che mi è scivolato addosso, che a pensarci viene nostalgia, la Mole illuminata con il logo è una piccola cicatrice che apre ai mondi del possibile. Ma quest’anno no, quest’anno bisogna curare le ferite più grandi, rimediare alle cadute nei burroni, lenire questo senso di irreale, questo stridere di ambulanze e mare profumato, di mascherine sulla faccia e un viso che non vedevi da febbraio, l’imbarazzato e atterrito stare, immobile, distante, senza poter fare gesti regolati da una prossemica naturale.
Non sono mai stata appiccicosa, anzi, sono ligure di scoglio e solitudine, eppure in queste due settimane ho incrociato persone per strada e le gambe sono andate da sole, ho dovuto frenare con un’accelerata della parte razionale: ma dove vai, cosa fai. Oggi camminavo, vedevo gente, ho visto un’amica, ci siamo parlate da lontano, io in piedi lei a cavalcioni del muretto. Il disagio. Sono io, a disagio. Senza mascherina, uscita per godermi una passeggiata rinvigorente, ma qui fa un caldo estivo, sembra di avere un phon puntato in faccia, la gente fa aperitivo col chiosco aperto senza tavoli, si arrangia come può, sotto il mare è da farci il bagno, sopra passano le volanti, biciclette, cani, runner e semplici gruppi di amici ritrovati.
Solo io non mi ritrovo. Mi sembra tutto diverso, bello e insieme strano: non ho le forze, la vita sociale è una scalata pesantissima, le persone vivono e fanno cose, io passo le giornate tra casa e un lungomare che fino a ieri era deserto, luogo tutto per me e i miei pensieri. Adesso invece in un attimo è già quella stagione così vivace e intensa che di passeggiate non è tempo, bisogna mettersi un costume e scendere giù, rinfrecare la testa in quell’acqua cristallo. Ci penso: uno di questi giorni me ne vengo alla spiaggia. Chissà se posso, chissà com’è. Intanto sorrido da sola perché mentre guardo giù vedo una ragazza che conosco attaccata allo scoglio. Legge. La vedo sempre, da anni, fa i miei giri, è spesso sola, spesso tira fuori libri, viaggia in bici. Dovrei mettere a posto la bici e provare a inserirmi in questo riprendere della vita che mi sembra del tutto estranea. Cammino con gli occhiali da sole, i capillari rotti fanno male, brucia tutto, ho paura di aver preso il virus, forse è solo qualche polline, forse anche basta leggere sempre fino alle due di notte, no?
Ho voglia di una passeggiata con un amico, un gelato, una pizza, un qualcosa, ma qualcosa di normale, che possiamo camminare a fianco, che possiamo riprendere a fare le cose normali, perché così è colloso e pesante e come rallentato, come ovattato, è una parola che mi ha detto al telefono anche il comandante della capitaneria. In giro, per terra, c’è sempre più plastica, rifiuti, vedo guanti, più di quanti ne ho contati la settimana scorsa, mascherine. Se c’è una cosa che mi ha presa, entusiasmata e coinvolta, in queste due settimane, è il mio lavoro fatto per un concorso sul tema mare all’epoca del coronavirus. Se le mie giornate e i miei lavori fossero tutti così io sarei carichissima, mica affievolita come oggi, che guardo foglie di aloe verde brillante pensando che a volte mi immagino cose, ma poi magari finisce che avevo ragione.
Cerco ispirazione in canzoni, ma l’ipod stravecchio non ce la fa: si spegne. Solo il rumore del mare e il ronzio di un peschereccio che fende l’acqua sotto costa. Dopo essere arrivati fino al Galeazzone, in mezzo al niente e dentro alla bolla aromatica sempre più forte di erbe, fiori, ginestre e salsedine, tornare alla civilità costa un po’. C’è pieno di gente, c’è ancora il capannello distanziato al chiosco, e io penso che non capisco come facciano tutti a stare così sereni. Che poi è anche bello, mi rinfranca vedere le cose che riprendono, i volti, il lavoro, le facce. Mi sembrano facce più rilassate, le penso – ci penso – come sopravvissuti dopo un’onda stravolgente. Lentamente, con movenze da bradipi, riemergiamo e torniamo a mettere fuori la testa. Fuori c’è il mare, perché qui funziona così, in questa stagione non c’ero mai stata, ed è così dolce e sereno che il resto non esiste più, che mi sento parte di questo posto, dove passeggio e conosco la gente, dove conosco la storia dei posti, la collocazione dei cespugli, dove sogno di tornare, dove osservo lo scorrere degli anni e delle stagioni, e calpesto sogni e desideri, anche oggi, dietro gli occhiali, mentre bruciano gli occhi e tengo a bada uno sgomento tutto nuovo. La ripartenza, nelle sere chiare e dolci dell’estate che è già qui.