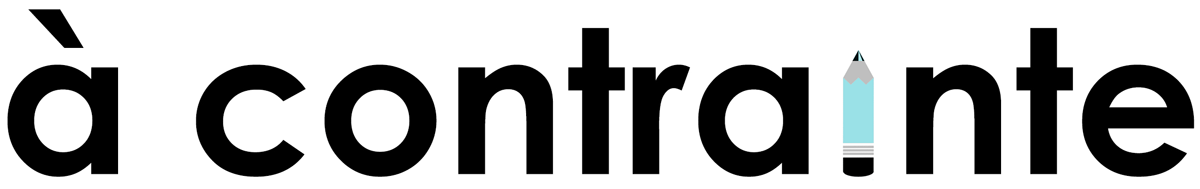È necessario che io scriva una premessa a questo mio pezzo dove racconterò di Una storia al contrario di Francesca De Sanctis (qui il suo sito), uscito di recente per Giulio Perrone Editore. È necessario perché si tratta di una storia vera, una storia di giornalismo e precariato, ed è quindi una storia che, più di tanta fiction, mi colpisce perché mi riguarda, e oltre alla me lettrice parla alla me giornalista precaria, trentenne un po’ frustrata e delusa, professionista senza storie eclatanti da raccontare ma, piuttosto, con molte storie al contrario di cui abbonda il curriculum.
È necessario che io scriva una premessa a questo mio pezzo dove racconterò di Una storia al contrario di Francesca De Sanctis (qui il suo sito), uscito di recente per Giulio Perrone Editore. È necessario perché si tratta di una storia vera, una storia di giornalismo e precariato, ed è quindi una storia che, più di tanta fiction, mi colpisce perché mi riguarda, e oltre alla me lettrice parla alla me giornalista precaria, trentenne un po’ frustrata e delusa, professionista senza storie eclatanti da raccontare ma, piuttosto, con molte storie al contrario di cui abbonda il curriculum.
Mi sarà impossibile essere oggettiva, mi sarà decisamente complicato non inserire riflessioni personali, commenti e amare riflessioni che dalla storia al contrario dell’autrice portano alla mia. Non per fare del vittimismo quanto invece, piuttosto, per continuare a fare il mio mestiere che è – sarebbe – quello di informare sui fatti. E sul precariato nel mondo del giornalismo poco sa la gente comune, e molto c’è invece bisogno di raccontare, di far vedere. Mi piacerebbe far capire come da articoli sottopagati, contratti stracciati o inesistenti dipendano le vite delle persone. Che poi è un po’ quello che fa Francesca De Sanctis raccontando la sua esperienza.
Ho scritto cosa è stato smettere di farlo, smettere di scrivere per lavoro, per vivere
Una storia al contrario è una storia vera, quella di Francesca De Sanctis, giornalista a L’Unità. Chi abbia un po’ di dimestichezza con le vicende editoriali degli ultimi anni saprà bene che la storia di vita del giornale fondato da Gramsci è piuttosto in salita e molto triste, per quel che riguarda l’ultimo periodo: un giornale la cui società è fallita, un giornale che non si sentirebbe tuttavia morto, con redattori vivi e presenti, che hanno lottato e accettato condizioni pazzesche. Eppure L’Unità al momento non esce in edicola, non è estinta ma non è neppure viva. Un limbo, una terra di nessuno in cui, una famiglia sulle spalle, una malattia, un sogno e un’identità professionale da coltivare, si è trovata a viaggiare piuttosto repentinamente la voce narrante e protagonista, giornalista quarantenne.
Dunque la protagonista ricostruisce il suo sogno di fare la giornalista, la sua ambizione coltivata fin da bambina: lacerti di vita familiare, affetti, vicende anche intime, gli studi, le opportunità, la carriera si succedono nel racconto. Mi ha colpito la parte dedicata all’università, il Dams di Bologna allora culla di nomi che sarebbero diventati anche i miei riferimenti anni dopo, i miei professori e maestri: Ugo Volli, Umberto Eco, Paolo Fabbri, per esempio. Come è piccolo il mondo della cultura in Italia: come sono sfaccettate le possibilità per chi nasce a dieci anni di distanza.
Ma torniamo alla storia al contrario che porta, giovanissima, Francesca De Sanctis al posto fisso a L’Unità, quel famoso contratto indeterminato detto Articolo 1 nel mondo del giornalismo. Per me, l’utopia: diritti, ferie pagate, maternità, tutele. Certo, per chi sogni di fare un lavoro e poi riesca effettivamente a firmare un indeterminato mettendosi al sicuro dalle incertezze professionali, deve essere un traguardo bellissimo, deve riuscire a sollevare e cementare quell’entusiasmo che poi è la benzina per continuare a fare bene il proprio lavoro.
Io credo che fare questo mestiere sia un grande privilegio, essere testimone di qualcosa che accade in quel momento davanti a te e poterlo raccontare al mondo è qualcosa di incredibile e richiede una grande responsabilità.
Quest’esperienza felice che De Sanctis narra di aver vissuto all’incirca alla mia età attuale mi ha generato un po’ di invidia. L’autrice lavorava alle pagine culturali del giornale, ne era diventata vicecapo. Una carriera perfetta insomma. È facile da capire: fai qualcosa che ti piace, ti danno responsabilità, tu accetti e cresci, fai bene il tuo lavoro, in quella professione ti identifichi e riponi il senso di te, di una fetta grande della tua vita. Tu sei il tuo lavoro, il tuo lavoro è quel che arriva, quasi artigianalmente, dalle tue idee, testa e mani sulla tastiera. Bellissimo: la perfezione. L’ho provata qualche volta, questa sensazione, dopo qualche intervista appagante, qualche pezzo piazzato bene, qualche giornata intensa senza orari che però era tutta dedicata al lavoro. È una sensazione solida e positiva. Ma è rara, se sei un precario dell’informazione.
Quando a Francesca De Sanctis accade di restare suo malgrado intrappolata nel vortice della crisi editoriale de L’Unità, avviene il primo scollamento da questo mondo fatato di interviste, teatro, arte e cultura, lavoro febbrile e costruttivo a contatto con i grandi della cultura e del giornalismo (a leggere che quando è entrata in redazione L’Unità era diretta da Furio Colombo, ho provato ammirazione sconfinata). Il lavoro c’era, e adesso non c’è più: tutti a casa, che sembra uno slogan forgiato per il covid, ma è una frase che i redattori de L’Unità avevano già imparato a far propria un po’ di tempo prima che l’attuale crisi desse il colpo di grazia a un sacco di lavoratori già precari e sospesi sul vuoto. Arriveremo tuttavia anche al covid e al lockdown, in questo racconto, che è freschissimo e pienamente attuale.
Un romanzo-biografia che si apre, non casualmente, con un esergo tratto dalle Lettere dal carcere di Gramsci che scrive al fratello Carlo, nel 1927: parole amare, parole limpide e oggi, applicate alla storia narrata tra le pagine di Francesca De Sanctis ma anche semplicemente riferite alla vita e al mondo là fuori, parole portatrici di grandi verità. Una carezza bruciante, se vogliamo, una consolazione che arriva da un grande personaggio e che in quanto tale, lo provo su di me, dà forza, coraggio, non fa abbassare la testa.
Mi sono convinto che anche quando tutto è o pare perduto, bisogna rimettersi tranquillamente all’opera, ricominciando dall’inizio. Mi sono convinto che bisogna sempre contare solo su se stessi e sulle proprie forze, non attendersi niente da nessuno e quindi non procurarsi delusioni. Che occorre proporsi di fare solo ciò che si sa e si può fare e andare per la propria via.
Se è possibile aggrapparsi a queste parole per resistere in un autentico terremoto di senso – senso generale, quello che stravolge le meccaniche del mondo dell’informazione, quello dei pezzi a quattro euro, dello sfruttamento dei freelance precari; ma anche senso personale, quello che si polverizza quando ti ritrovi nel pieno della vita senza il lavoro in cui avevi investito tutta te stessa, che amavi e ti dava struttura, pienezza, gioia seppure in mezzo alle onde -, Francesca De Sanctis lo fa, e io la seguo. Lei lo fa in mezzo a una burrasca editoriale e aziendale di cui il giornalismo in sé e i colleghi non sono responsabili: ci si trova, suo malgrado. Da un’idea di vita trasformata in realtà e pienezze, la storia si rigira su se stessa, diventa il contrario e finisce punto e a capo, con un lavoro che non c’è (più) e tutto da riscostruire.
È certo una posizione sfortunata e frustrante, un po’ assomiglia a quella di altri precariati nati così fin da subito, storie al contrario autentiche, mattone dopo mattone di una costruzione che non ha mai creduto di poter essere stabile ma si è accontentata di stare su perché era l’unico modo per avere qualcosa. Questa è la mia esperienza, ed è per questa storia al contrario che le parole di Gramsci danno forza nell’amarezza. Perché è così: nessun collega ti aiuterà, anzi, ti arriveranno pugnalate alle spalle o sorrisi sterili senza che ti venga tesa una mano; le ingiustizie il cui perno è la totale mancanza di meritocrazia saranno all’ordine del giorno; ne deriveranno delusioni cocenti, cinismo di diamante che lacera gli entusiasmi, la voglia, toglie senso allo sbattersi. Si è soli, col desiderio bruciante di scrivere per vivere, con un curriculum che attesta delle capacità e delle esperienze, senza tuttavia interlocutori né vie d’uscita da un vicolo cieco la cui gabbia è un muro invalicabile.
Quando perdi il lavoro non perdi solo le chiamate. Se ne va un pezzo importante di te, quello che avevi costruito col tempo e che d’un tratto è stato bombardato, sventrato. Caduta sotto il fuoco nemico. Già il nemico, ma chi è il nemico? L’azienda? Un bilancio in rosso? Una linea politica sbagliata? Il mercato? Il PD? La risposta purtroppo non cambia la situazione. A mutare, invece, sono gli sguardi della gente.
Ho trovato molta paura, nelle parole di Francesca De Sanctis, ma ancora qualche goccia di ideale, di speranza, che arriva probabilmente dalla felicissima esperienza di redazione avuta in uno dei giornali storici italiani. Lavorare in redazione, lavorare con la redazione. Confesso che ho provato e provo invidia: a me non è mai capitato di essere inserita in un organico e di lavorare fianco a fianco per il bene del giornale, dell’informazione. Sempre e solo invidie, lotte, bugie, esclusioni, falsità. Precariato e solitudine, che sono poi i mali che affliggevano già prima questo mestiere, quello di chi fa informazione, e che con il covid sono diventati il morbo assoluto. Come campi, come ti ri-inventi quando ti buttano fuori dalla redazione e da un giorno all’altro tu che cercavi le notizie, le scovavi, intervistavi, organizzavi le uscite quotidiane, sei senza lavoro? Provi a fare il freelance, perché di editori che non pagano, promettono e non rispondono, ti sorridono falsi mentre sprofondi nel burrone – e lo vedono, lo vedono bene – ne hai visti troppi. Perché insieme al modo di fare informazione non vuoi sprofondare pure tu, che ci metti i tuoi valori e la tua visione del mondo, nel tuo lavoro.
Freelance: proporre pezzi, saperli prezzare, soprattutto avere i contatti giusti. Che, come racconta Francesca De Sanctis, se esci da anni di lavoro a L’Unità hai, e ti può persino andare bene. Se sei un anonimo cronista locale, col piffero, e la conseguenza è che ci provi in tanti modi, ti sbatti, studi, provi e riprovi, ma le risposte o non arrivano o sono “no, grazie”. È una frustrazione che capisco, quella di vedersi un pezzo pagato poche decine di euro, e di doversi arrovellare per cercare altre entrate, un logorio che l’autrice di Una storia al contrario ben descrive. Ma che fa crescere la mia amarezza quando tra le pagine leggo di critiche ai giovani, che, arrivisti e smaliziati, accettano pezzi pagati niente per fare carriera. Sarà pure così, in mondi remoti che non conosco, ma nel mio mondo c’è solo che se sei un freelance sconosciuto che arriva dalla cronaca locale, non ti si fila nessuno. Per mesi, per anni, e tu continui come un dannato a provarci, e alla fine magari sì, accetti le schifezze, perché sei logorato dentro. Quindi no, quelli come me non rubano la carriera e i pezzi a nessuno: quelli come me sono ancora più sfigati dei quarantenni che almeno un pezzettino di vita redazionale l’hanno fatto. Proprio per questo, e per l’anonimato, a quelli come me non li accettano quasi mai, i pezzi da freelance: giornalisti precari e formati sulle proprie esclusive forze e abilità, giornalisti che la felicità sul lavoro non l’hanno quasi mai conosciuta, che non avranno pensione, che per fortuna hanno il welfare familiare, che un mutuo se lo sognano, che hanno avuto bisogno della firma dei genitori a garanzia per l’affitto.
Come si fa a vincere questa battaglia assurda contro cui una generazione intera, quella dei quarantenni, quella di mezzo, non riesce a trovare una via d’uscita? Se guardo avanti penso a una pensione che non arrriverà mai. Se guardo indietro vedo i miei anni felici come qualcosa che non tornerà più. Se guardo al presente vedo solo la mia splendida famiglia da mantenere e un mutuo da pagare.
Tengo presente che quella di Una storia al contrario è un’esperienza singola, appartiene alla sua autrice e, per quanto tocchi svariati punti universali e una precisa testata, L’Unità, resta il racconto di qualcosa di soggettivo. Però mi preoccupa che si legga questo del giornalismo: mi preoccupa l’amarezza delle riflessioni sul modo di fare i freelance, che è una guerra tra colleghi e una guerra quotidiana per accaparrarsi un numero congruo di uscite e quindi pagamenti. Questa è la realtà che si vive da anni, qui fuori nel Bronx, mi ferisce leggerne come di un’esperienza terribile che capita a una redattrice improvvisamente senza lavoro: c’è chi il lavoro non è mai riuscito ad averlo, e certo non per colpa sua. Mi preoccupa che si ripeta diverse volte che i giovani sono agguerriti e incattiviti. Lo saranno forse i ventenni, che hanno capito da prima come funzionava il mondo e si sono costruiti una dotazione adeguata per superarne gli ostacoli bestiali. Noi trentenni, invece, siamo dimenticati: esistenze precarie che non si aspettano più niente, che finiranno per non credere in niente, portone dopo portone preso sul muso per colpa del solo fatto di essere nati in un decennio che ha segnato la nostra crescita. Tra la crisi del 2009 e quella del 2020 avremmo dovuto poter costruire il nostro futuro, ma tutto crollava, e quel che abbiamo racimolato è polvere.
Per questo motivo la lettura di Una storia al contrario mi ha fatto molto male: è una storia che mi riguarda, le cui paure e angosce provo sulla mia pelle anche se arrivo da un’esperienza del tutto diversa. Diverso è il punto di vista: alle speranze che accompagnano il finale, macerie di una carriera su cui ricostruire una nuova storia professionale e familiare, io non credo più. Qui si apre dunque la faglia che mi permette di approcciarmi a questa storia come quel che si propone di essere: un romanzo. Una singola storia raccontata con il suo punto di vista, i suoi personaggi, la sua evoluzione. Una storia simile alla mia, capace di puntare la luce su quelle ombre reali che affliggono la mia professione. E questo deve fare una bella storia: illuminare, proporre percorsi, accendere interrogativi. Il mio interrogativo su questa allucinante e bellissima carriera non si spegne dunque nonostante la plateale amarezza che ormai lego al tema. Quell’irrefrenabile voglia di mettersi al servizio delle storie e raccontarle è la molla che si accende in chi di noi sogna di fare giornalismo, e quella cosa lì non smette, non smette mai di punzecchiare e carburare proponendo idee e scappatoie davanti agli ostacoli. Come Francesca De Sanctis, riparto da qui, non ho mai smesso di farlo: se non trovassi senso nei vincoli e negli ostacoli, del resto, non avrei messo su un sito che si chiama A Contrainte.