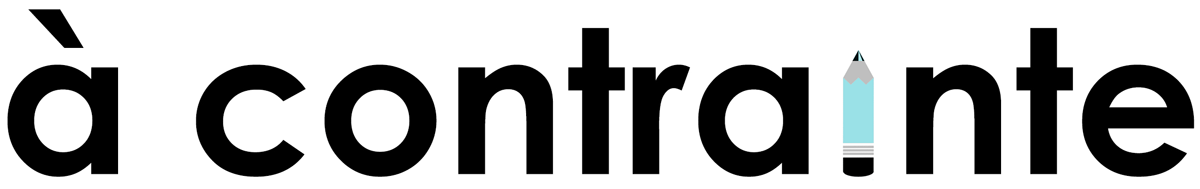È la notte tra il 5 e il 6 gennaio. Fuori dalla finestra lame fredde di vento gelido, tramontana che annuncia il pieno inverno anche se siamo al mare. La Befana me la immagino coperta e incappucciata di tutto punto, viaggia solitaria nella notte, un ultimo giro di dolci, sorprese e rilassamento prima che il weekend che si apre si porti via tutte le feste, lasciando un po’ di vuoto, un po’ di freddo, un po’ di impaccio nel ritorno alla realtà.
Quale momento migliore, allora, per accantonare tutti i libri (ben quattro) iniziati nel 2016 e traghettati nell’anno nuovo senza essere finiti, e aprirne uno nuovo? Spinta dalla voglia di “cambiare aria” e sollecitata dall’imminente scadenza del tempo della magia natalizia, ho optato per “Il pastore d’Islanda“, di Gunnar Gunnarsson, prima traduzione italiana a cura di Maria Valeria D’Avino di un’opera molto famosa in tutto il mondo, planata in Italia alle soglie dell’Avvento, lo scorso autunno, grazie a Iperborea.
La prima premessa è che amo il lavoro editoriale di Iperborea che, forse lo saprete o forse ancora no, pubblica autori nordici, la seconda premessa è che il mondo scandinavo e baltico mi è totalmente ignoto, estraneo, ed è per questo che la sua letteratura mi suscita molta curiosità. Terza premessa, o forse solo trampolino di lancio, è che “Il pastore d’Islanda”, ieri notte, è stato il primo racconto che abbia letto ambientato in Islanda e frutto del lavoro di un autore islandese. Un’isola sperduta in mezzo ai ghiacci, col fuoco vulcanico nelle viscere, una popolazione abituata a grandi freddi e grandi spazi deserti, ad alternanze luce-buio insolite per noi mediterranei: insomma un posto strano, dove alla magia del Natale che di questi tempi (ancora per poco!) si respira e si associa al grande Nord, si somma un confronto serrato con le forze della natura. E dunque Gunnarsson non poteva che appagare al meglio la mia voglia di simili scenari.
Bando alle ciance, “Il pastore d’Islanda” è un racconto lungo, quasi una favola di Natale, scritta negli anni ’30: una narrazione che in un sol colpo rapisce e porta lontano nello spazio e nel tempo. Protagonista è Benedikt, il pastore del titolo, che insieme ai suoi amici – amici, non solo meri accompagnatori o aiutanti – affronta un viaggio sui gelidi altipiani islandesi, tra le montagne, nel mese più rigido, cioè dicembre, alla ricerca delle pecore sperdute durante il rientro al pascolo dell’autunno. Benedikt non salva le pecore per scopi utilitaristici o per suo tornaconto: le salva per salvarle, per rendere un servigio alla sua comunità rurale. E già qui, sullo scopo immacolato di quest’ometto che, 54enne, si ritrova a fare per la 27esima volta il viaggio in montagna, ci si allarga il cuore, siamo quasi straniti davanti a cotanta purezza. Non fosse che Benedikt va in montagna insieme ai due amici speciali: Leò e Roccia. Amici a quattro zampe, un cane il primo, cane da pastore, forte, intelligente, seppure caciarone a volte, un montone, il secondo, mite e solido, come ricorda il nome, ce lo si immagina coperto di pesante pelo lanoso, che avanza sprofondando nella neve senza però mai farsi abbattere. I tre si avviano per l’avventura, come consuetudine, il giorno dell’inizio dell’Avvento (il titolo originale del racconto è infatti significativamente “Advent”): la santa trinità – così li chiamano – in cammino.
E come ogni cammino, seppure già noto perché percorso e ripercorso, anche in questo caso arriveranno ostacoli, problemi, piani risolutori e cambi di traiettoria. Un vero “Avvento”, insomma: un percorso di scoperta e riscoperta, insieme di riflessione, di superamento di difficoltà, di considerazioni e anche, infine, di cambiamento. Una piccola rivoluzione su e giù per le montagne, con qualche pizzico di riferimento religioso, a partire dal titolo e poi nei pensieri di Benedikt, che ci fa sapere dalla pagina di Vangelo letta alla partenza che quel giorno Gesù entrava a Gerusalemme salutato con rami di palma verdi, col sole dentro (le palme verdi nell’immaginazione di un pastore dell’Islanda mi hanno colpito, lo confesso).
Tutto questo sviscera alcune considerazioni. Innanzitutto lo scenario: le grandi descrizioni dell’Islanda dei ghiacci. Montagna, rifugi caldi, solidarietà tra uomini del grande Nord, e poi bufere di neve, barba e pelo degli animali ghiacciati. Una sfida costante in mezzo a una natura che non è mai male, è, e basta, come sa bene Benedikt che quelle montagne le conosce, le rispetta, le ama senza mai odiarle, anche se lo mettono in pericolo. Quelle montagne sono vere, è la forza dirompente della terra islandese, ma sono anche simboliche, sono le montagne di ogni cammino umano: “Anche se tutto ghiaccia, se si rapprendono le pietre e l’acqua, se l’aria gela e cade giù in fiocchi bianchi e si posa come un velo nuziale, come un sudario sulla terra, anche se il fiato gela sulle labbra e la speranza nel cuore, e nella morte il sangue nelle vene – sempre, nel centro della terra, vive il fuoco”.
Poi, ancora, la storia del pastore che non cede di fronte a nulla pur di realizzare il suo scopo. Un po’ pastore leopardiano, sperso nel deserto (di ghiaccio e non asiatico), un po’ uomo comune, Benedikt, pur nella sua semplicità, di cui è consapevole, non smette di interrogarsi su di sé, su Dio e sul mondo. Dal suo cammino gelido e solitario snocciola e racconta una filosofia del mondo, una visione fatta di piccoli gesti di fedeltà a sé e alla natura, ricamati a intessere un grande destino umano, non solo proprio ma comune e condiviso. Ama le montagne, la solitudine che vi si respira e che gli permette di adempiere al suo compito immerso nella riflessione su sé e sul mondo: “nel mezzo di quel mondo raggelato che si dissolveva nelle tenebre, come se fosse anche lui parte della sera buia, c’è l’uomo Benedikt, mezzo servo e mezzo contadino, è lì con i suoi amici più fedeli, il montone Roccia e il cane Leò – e quel mondo è il suo. Lì vive ed è parte di tutto quello che può abbracciare con lo sguardo e con le mani, con i pensieri e con i presentimenti. Quel mondo è suo. È parte di questa vita”.
Infine, la citazione sopra non può che condurre qui: alla poesia. Dentro questo racconto infatti c’è la poesia scaturita dall’incontro de due precedenti aspetti: un uomo che riflette in mezzo alla natura selvaggia. Un uomo che si mette in marcia con gli amici più fedeli nel periodo che precede il Natale, la festa della gioia, del calore, della riconciliazione tra uomini. Quando Benedikt si mette in cammino pensa spesso che sta compiendo la sua impresa ancora una volta, sulle stesse orme da 27 anni a questa parte, il giorno di inizio dell’Avvento: “L’Avvento! Sì…Benedikt pronunciò con cautela quella parola grande, mite, così esotica e al tempo stesso familiare. Forse, per Benedikt, la più familiare di tutte. Certo, non sapeva di preciso che cosa significasse, ma c’era in ogni caso l’attesa, la speranza, la preparazione – questo lo capiva”. Un libro, una favola di Natale, che è un piccolo gioiello di scrittura e di gioia, lo dice inconsapevolmente l’autore stesso descrivendo il viaggio di Benedikt, la sua dedizione nella difficoltà, accompagnato dagli amici in una strada montana che si fa salita allegorica, cammino di vita: “quel viaggio era come una poesia, con rime e parole magnifiche che restavano nel sangue. E come una poesia, col tempo s’imparava a memoria e poi si sentiva il bisogno di tornare, per accertarsi che nulla fosse cambiato. E così era: tutto era ancora estraneo e inaccessibile, eppure familiare e inevitabile. Benedikt si sentì invadere da una pace assoluta. Una fiducia sgorgata dal profondo si diffondeva in lui, totale e infallibile: lì camminava. Camminava lì”.
Ogni Natale – ogni Avvento – Jòn Kalman Stefànsson, noto autore islandese tradotto in Italia da Iperborea, rilegge questa favola, questo lungo racconto, così come racconta nella postfazione. Molto ci sarebbe da riflettere sulla biografia dell’autore, sulle caratteristiche della letteratura islandese e su tante caratteristiche “tecniche”, ma no, non è quello il punto di questa caldissima – seppure gelida nelle sue descrizioni – lettura che mi è capitata un po’ per caso un po’ per decisione sul finire del periodo natalizio. Il punto forse è la sua semplicità delicata e forte al contempo, che così bene si confà al percorso che porta al Natale, e così bene, come lo spirito del Natale, corrobora lo spirito, riscalda e illumina dopo periodi di scalata buia e gelida. È vero: questo racconto andrebbe riletto, rannicchiati sotto a una calda coperta per combattere il freddo che sente Benedikt e resistere accoccolati con lui e i suoi amici nel rifugio sotto la neve. Andrebbe riletto ogni Natale, come uno sciroppo, una tazza di tè profumato col miele, una cioccolata in tazza. Perché riscalda il cuore, come tutte le cose apparentemente semplici e magari distantissime da noi che – sarà la magia del Natale? – raccontano la nostra quotidianità. E dunque, felice di aver acciuffato questa lettura nel tempo giusto del calendario, se “l’Epifania ogni festa si porta via” sarà bello cercare di non mandare via il ricordo del pastore d’Islanda e dei suoi amici nello scomodo ritorno alla quotidianità.