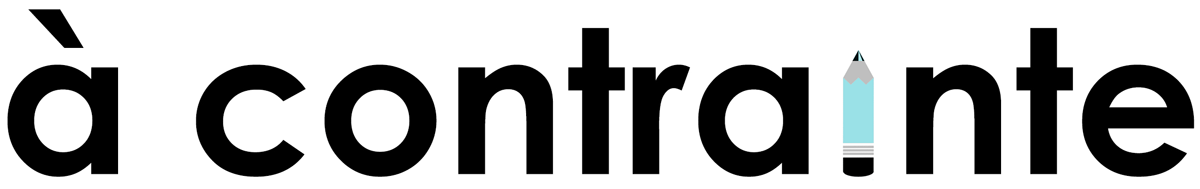Prima o poi questa storia della felicità e dei trentenni diventerà un tema sociale, ne sono convinta. Accadrà quando ormai sarà tardi, quando gli attuali trentenni, quelli che nella morsa degli interrogativi sulla felicità ci stanno perdendo la salute, oggi, avranno ceduto a qualche forma di compromesso per sopravvivere.
Non mi sembra un caso che siano usciti in libreria a relativa breve distanza due libri come I felici, della tedesca Kristine Bilkau, e Il pieno di felicità, dell’italiana Cecilia Ghidotti, edito da Minimum Fax. Non mi sembra nemmeno un caso aver trovato diversi parallelismi tra i due romanzi, tra cui spiccano tre cose lampanti che emergono dalla pagina per toccare la me lettrice. Il primo: reali problemi di precariato che mozzano la visione lunga, rendono impossibile pianificare un futuro, tirare il fiato, rilassarsi, e si riversano su una miriade di sintomi di stress, tic, nervosismi vari. Il secondo: il fastidio. Il fastidio dei protagonisti di queste storie di lavoro, mancanza di lavoro, ricerca e vacuità della ricerca, che si percepiscono come naviganti del vuoto, e non hanno mai, mai davvero, la certezza di essere arrivati, di essere qualcuno, una professione, un ruolo nella vita, un luogo. È il fastidio che provo anche io, per i personaggi che mi sembrano inetti, per l’inetta che forse nella vita sono anche io, visto che assomiglio a loro.
Il terzo punto è quello che riguarda le classi sociali che, a dispetto di quanto si possa pensare, esistono eccome, e riguardano, con questo stridìo imperante del precariato di quelli della mia generazione, la classe borghese, giunta al collasso e tanto intelligente da intuirlo, quel collasso. Peccato che una soluzione non sia ancora così pienamente possibile: il sistema resta più forte.
Ma facciamo un passo indietro, nel libro della Ghidotti. Un romanzo strano, una sorta di autofiction che mescola una larga parte di elementi biografici con quella chimica narrativa fatta di finzione e necessaria a garantire il giusto ritmo e respiro alla narrazione. Cecilia ha finito un dottorato a Bologna, non ha ancora pubblicato la tesi, si trova davanti uno sterminato mondo di possibilità e impossibilità, le serve tempo, e mentre lo cerca il mondo va avanti, la trascina a Coventry, dove il fidanzato sta svolgendo il suo dottorato. Schiacciata dalla piattezza e vuotezza di una cittadina inglese piuttosto morta, la protagonista continua a vagolare alla cieca, piccoli contratti in biblioteca all’università di Coventry, altri tentativi che la portano a Londra, con tutta la fatica del pendolarismo, ma che non le danno futuro. È tutto a scadenza, è tutto precario. Le nevrosi aumentano, l’Italia manca.
A mancare è anche, soprattutto forse, il concetto di casa, la visione solida di “casa”: è lo sconto da pagare per questa generazione, e per la sua parte più brillante e globale che ha fatto dell’erranza uno stile di vita, che passa un weekend sì e uno no su voli low cost, che si trasferisce all’estero mentre attende di capire qualcosa, che qualcosa cambi. Tutti gli ambiti e settori, per questa generazione, sono così, ma se a trent’anni ti trovi invischiato nel mondo della ricerca accademica, la situazione si fa ancora più vertiginosa, soffocante a tratti. Compromessi, ricatti di vita, buchi, città da conoscere, dove gettare nuove vite, meccanismi da imparare. Imparare, Cecilia lo dimostra con le sue difficoltà con l’inglese, con i suoi colloqui e con il secondo dottorato: non si smette mai, non sarebbe possibile, in questo tipo di sistema. È faticoso, e dato che non porta a niente di solido, ma solo a fantasmi labili, finisce per essere distruttivo. Gente iperformata con l’orizzonte di futuro ridotto a una manciata di anni. E poi? Il pensiero della provincia di origine, l’idea di tornare “a casa”, la prima casa, sfiora Cecilia, così come i protagonisti della Bilkau, così come me: tirarsi fuori dall’agone, respirare un attimo, prendere tempo mentre si cerca di capire.
Io credevo che a un certo punto avessimo stretto un patto che prevedeva che non saremmo mai tornati nei posti dai quali avevamo deciso di andare via. La cosa giusta per diventare adulti era rinunciare ai privilegi che derivano dal vivere in luoghi familiari: trovare una strada senza dover tutte le volte impostare un indirizzo su una mappa, avere una macchina a disposizione senza necessariamente possederne una, avere amici di amici che conoscono un idraulico e un falegname a prezzo sensato, e i genitori vicini quando c’è bisogno di essere aiutati; o di aiutarli.
Il tema di questo romanzo che, lo ripeto, per la sua forma di autofiction è assai strano nei toni e nella struttura, è fondamentalmente la frustrazione, io credo. E frustrata è la protagonista, che dall’alto dei suoi privilegi sociali, di cui è consapevole, si permette di alzarsi tardi la mattina e finire per perdere tempo. In tutto il resto del tempo – mentre non lavora, non trova un lavoro e forse non sa nemmeno dove cercarlo, se in Italia o nel Regno Unito, o altrove ancora – lo passa a pensare. Pensare come nevrosi, pensare come andare indietro e rianalizzare le scelte fatte, gli snodi, e ricordi, e percorsi intrapresi e poi forse mai chiusi o finiti come non erano iniziati. Alla ricerca di un buco, del momento dello sbaglio?
Sarò sincera: ho provato antipatia per la protagonista, in balia di una situazione che sì, non è facile, ma anche di un ego imperante, un filo sfacciato. La nevrosi ci porta a questo, all’autoreferenzialità? La teoria della classe disagiata – libro esplicitamente citato nel testo – dice la verità e dà spazio e parola a una classe di privilegiati che sentono di meritare quella visibilità, ma sono in realtà l’emblema di falliti? Lo scacco è qui: sparito il privilegio economico derivante dalle competenze, la mia generazione dovrebbe diventare working class, adattarsi a uno stile di vita diverso, “povero”, senza quei privilegi dati da belle case, mezzi di trasporto, viaggi e vacanze. Siamo pronti a questo? La protagonista, di sicuro, no. E l’umiltà di porsi davanti a questo tormentoso dubbio non l’ho trovata: ci ho visto tanta, troppa pretesa. Per come vivo io la situazione, di sicura contraddizione e mai semplice, mai lineare, preferisco viaggiare con l’ego meno guerrigliero, ma con una vagonata di dubbi in più che di certo non contribuiscono a facilitare il tutto, anzi. Sarò io a sbagliare? Mi chiedo anche questo.
Penso al privilegio enorme che abbiamo avuto nell’iniziare a lavorare tardi. È stato un privilegio di classe e nello stesso tempo non c’erano alternative. I primi a scrollarselo di dosso sono stati i non garantiti; i figli di quelli che avevano finito i risparmi dei nonni, oppure quelli che pensavano di poter contare sui genitori all’infinito e invece la loro morte si è rivelata all’improvviso, lasciandoli con i debiti da pagare e le macchine da vendere. Io posso ancora permettermi l’inversione di ruoli, posso permettermi di essere quella piccola cui bisogna dire le cose con cura, quella da ringraziare per aver partecipato.
Al fondo di tutto, sarà che c’è sempre lo spettro di una debolezza, di un fallimento. Non per niente la protagonista ogni tanto si sente una piangiolina, una che quando piange è vista dagli altri come una debole, ridotta così da un’educazione morbida, incapace da adulta di affrontare la cattiva sorte. La felicità, come accadeva nel libro della Bilkau, resta qualcosa di labile e sottile, molto fragile rispetto agli edifici solidi delle generazioni che ci hanno preceduto. Deve essere un segno dei tempi. Mentre nessun’altro ha ancora avuto idee diverse o trovato soluzioni alternative a una vita che scorre nei binari dell’oggi e casomai del domani, ma mai del dopodomani, faccio tesoro del fastidio che questi personaggi immobili mi hanno generato. Umilmente, con circospezione e sguardo aperto sul mondo, continuo a esplorare.
Quando ero alla presentazione del romanzo, a Torino, ho sentito l’autrice snobbare l’idea che Il pieno di felicità fosse un romanzo generazionale. Termine brutto, termine abusato. Tuttavia, non sarà generazionale ma resta infarcito di riferimenti mediatici, televisivi, musicali che raccontano la mia generazione: cartoni animati, La casa dov’è di Jovanotti, i festival musicali, le canzoni e i loro testi come inni di vita, lo Zecchino d’oro, da cui deriva proprio il titolo del romanzo. Ci si riconosce, da lettori coetanei, si fa incetta di riferimenti intertestuali che forse non saranno necessari alla comprensione globale del testo ma che, intesi, colti, analizzati e ripassati con la memoria personale, ricostruiscono un’epoca intera. Forse è proprio l’epoca in cui i presupposti per un futuro diverso e pronosticabile si stavano sgretolando, e noi trentenni di oggi, angosciati da amiche incinta o che si sposano mentre noi non abbiamo nemmeno capito dove abiteremo e quale città sarà la nostra, eravamo intenti a costruire immaginari foraggiati dai media.