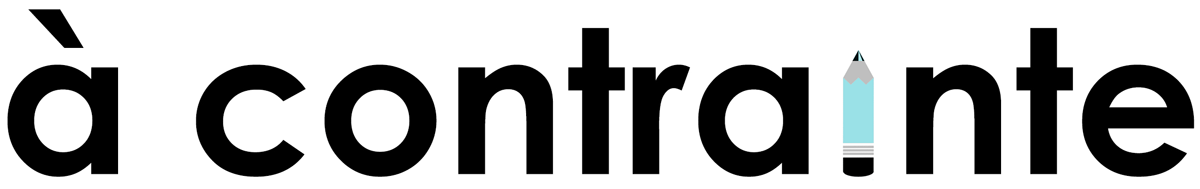Se ci metto un attimo di troppo a calcolare il giorno a cui siamo arrivati oggi con questo diario è sintomo del fatto che sta diventando realtà? Insomma: è il giorno 5, il giorno della bellezza, dell’open access, della condivisione. La giornata che porta al venerdì, ci conduce nel primo weekend di quarantena ufficiale. Quella totale, quella di tutta Italia.
Ci stiamo abituando. E tutto si allegerisce un po’. La giornata si avvia sempre davanti a questo schermo, perché il lavoro, lui, non si ferma, non ancora: c’è tantissimo da raccontare, c’è un weekend da allestire e servire come una programmazione televisiva. E allora si fa. Ma poi ci sono i libri gratuiti offerti dalle case editrici, ci sono i giornali che aprono gli abbonamenti, ci sono i meme, quanti meme, le battute, iniziano a fioccare i video.
Le liste sul quaderno vengono piano piano spuntate. Si lavora indefessi, si procede con metodo. Metodo: lo stesso che io e mia madre utilizziamo per uscire, munite di autocertificazioni. C’è macaia oggi a Imperia, nuvole basse dal mare. Scimmia di luce e di follia.
Che poi, in effetti, arrivi in centro, trovi il deserto e qualche raro essere umano con le mascherine e ti viene da pensare che la follia probabilmente si è impossessata della realtà: ci siamo dentro, la abitiamo, e stringe e stressa come le mura di casa. Tu vai a fare la spesa, io vado in farmacia: ci vediamo dalla nonna.
E si parte. L’impresa che mi spetta è la farmacia. Per arrivarci devo attraversare quelli che in tempi normali sarebbero i portici. Cioè, lo sono ancora i portici, ma risuonano come un tunnel vuoto. Deserto che rimbomba solo del ronzio del macchinario con cui uomini in tuta integrale bianca con cappuccio stanno pulendo le vie del centro. Mi infilo in farmacia. Ho una persona davanti, mi fermo a debita distanza. I farmacisti sono silenziosi, camice bianco e mascherina. La paratia di plastica, come in banca, è il dettaglio nuovo che si aggiunge alle mascherine e mi fa sembrare tutto più inquietante.
Vorrei chiedere Scusate ma come vi sentite, scusate ma la patite la differenza, scusate ma… Scusate: sono solo un essere umano. Lei, la farmacista che di solito è sempre in cassa, deve intuire il mio stato d’animo tra i capelli schizzati dal cappotto, che ha il colletto tirato su neanche soffiasse tramontana e dovessi ripararmi, e le occhiaie che parlano della mia notte di poco sonno. Non la vedo in faccia, o meglio, vedo solo gli occhi, vedo che mi sorridono.
La strada che mi separa da casa di nonna è breve. Breve e densissima: è il cuore della città deserta. Ci sono il panettiere, del quale oggi si sente il profumo nell’aria grigia, c’è la casa del mio migliore amico, e il retro della sua libreria chiusa. Io lo so che lui è lì dentro a lavorare. Mi guardo intorno, fortuita: mi seguiranno? Mi chiederanno? «Pronto? Esci, sono qui davanti»: dialoghi carbonari all’epoca del Coronavirus. Però una testa pelata si intravede dietro le sbarre: un paio di parole, c’è una sogliola per terra e no, non sto impazzendo mentre scrivo. Che Douglas Adams ci assista: grazie a chiunque – umano o gabbiano – abbia seminato una sogliola spiaccicata per terra in mezzo a una piazzetta ligure col pavimento in cotto. È così assurdo che va a nozze con il clima che viviamo. Sarà la macaia: scimmia di luce, follia, e sogliole di città.
Un momento: la chiesa è aperta. Schivo un paio di persone delle quali evito lo sguardo perché mi sembra brutto deviarle come fossero appestate, mi vergogno e abbasso gli occhi: lo so che mi perdoneranno, lo so cosa provano. Io, per esempio, sto malissimo. Così male che i cartelli che indicano che non ci saranno messe mentre siamo in piena Quaresima diventano un irresistible soggetto per delle fotografie. Devo ricordarmi di questi momenti, devono restare impressi: dobbiamo testimoniarlo a chi domani ci chiederà come ci sentivamo.
Entro in chiesa, c’è un uomo con la mascherina, mi vede, esce. Il gesto congelato di porre la mano all’acquasantiera: guai! Ho già aperto il portoncino con il gomito, figuriamoci mettere le mani nell’acqua. Dunque le metto su una candela: un gesto spontaneo. Quando penso che sto usando le mani è già troppo tardi, perché le sto già usando. Non c’è nessuno. Nessuno. Resto timidamente in fondo in mezzo al buio e a un santo che mi guarda benevolo col suo rosario in mano. Non ce la faccio nemmeno a concentrarmi un attimo fuori dalle preghiere rituali che recito quasi fosse un proforma. C’è troppo da capire: troppo che mi sovrasta. Oggi non è ancora il tempo per esplorazioni profonde.
Per fortuna c’è il lavoro: mi permette di concentrarmi su qualcosa. Dura poco: le notifiche imperversano. Un caffè, una tisana, una spremuta. Adesso quando finisco poi faccio eh, adesso aspetta c’è ancora una cosa, no poi però se faccio questa ecco no, ancora. È sera quando su Facebook arriva il primo video di un venerdì sera che si scalda per uscire metaforicamente a festeggiare il weekend. È un tre quarti bellissimo di Accordi Disaccordi “home version”, Rue du midi. Lo condivido. Oggi è tutto condiviso, fiumi e cascate di condivisioni di bellezza: in qualche modo dobbiamo salvarci.
E sono ormai le otto di sera, nulla di concluso nella mia bolla di relax inesistente, quando capito su un video di via San Massimo a Torino. Balconi, chitarre, voci e Lucio Battisti che risuona per la via fantasma tra la Mole e La canzone del sole. Le mani applaudono, i cani abbaiano, la gente esce e sembra quasi il gioco dei nove, tutti alla finestra. Aspetta, guarda, c’è un altro video: una mansarda, un commento, un violino in san Salvario, “ti mando un po’ di bellezza”.
Piango ridendo, o forse rido piangendo. Mi invade il cuore una commozione profonda che mi porta alle lacrime: come è tutto bello questo strano episodio di fuga di note dai terrazzi. La gente che esiste, che resiste. Le immagini che fanno rumore, no, anzi, fanno suono, fanno armonia. Un’armonia preziosa e unica di sguardi oltre le finestre, viste che vanno oltre, pescano lontano, abbracciano, leggono messaggi, hanno letto storie e le utilizzano per spiegarsi la realtà. E io rido piangendo, e piango ridendo perché i tetti di Torino che suonano mi fanno mancare la mia città adottiva, perché è grande lo spirito che sotto la Mole aleggia e bussa qui nella piccola città di mare e macaia, avvolte dalle spire della sua silenziosa quarantena.
Oggi vorrei condividere tutta questa bellezza con tutti, vorrei essere grata con tutti per la bellezza che sanno condividere, che sanno creare, e che regalano affacciandosi a un terrazzo. Sono commossa: gli italiani che fanno musica in terrazza sono una poesia epica, nostalgica, una grazia creativa nostrana che non voglio dimenticare quando sarà finito tutto e ripenseremo a questo periodo.
The Guardian, 13 marzo 2020: «People across Italy have been singing from their balconies in an effort to keep up morale as the country faces the worst coronavirus outbreak outside China. Italy’s 60 million citizens were placed under lockdown to halt the spread of a virus that has so far claimed over 1,000 lives in the country».
La sera guardo Propaganda Live come ogni venerdì, e in una puntata stranissima dove Zoro torna addirittura a fare i video old style e ci promette che torneremo tutti a ballare – e sarà bellissimo – acchiappo il brano che cullerà questi pensieri: My favourite things, John Coltrane.
Leggi tutte le giornate del mio diario di quarantena: 25 giorni a casa.