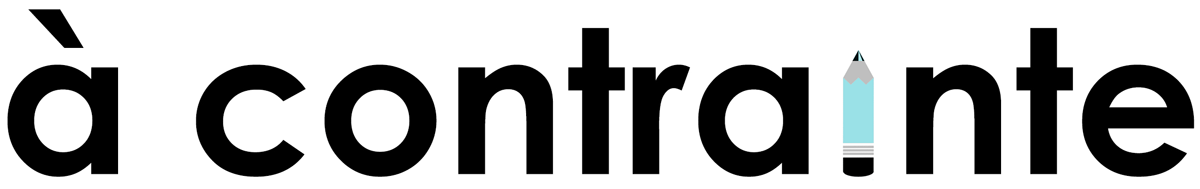Lenta, lentissima la giornata di oggi. Senza, sostanzialmente, nulla da fare. Non c’è nemmeno il sole, un sabato di aprile triste e grigiolino, con l’aria calda che promette l’estate che sarebbe, in un tempo sospeso colloso come il mio lievito madre, che si è acidificato e ha bisogno di interventi speciali per riprendersi.
Questa, una delle cose da fare. Perché qualcosa da fare lo trovo in ogni caso: scrivere il diario, constatare che sono quaranta giorni che, ogni giorno, senza mai disattendere, riverso qua sopra quello che penso. A che serve? All’inizio dovevano essere 25 giorni, tanti ma tutto sommato limitati: pensavo sarebbero state 25 pagine per registrare pensieri, avevo in mente di prendere in esame certi concetti, determinate parole chiave, avevo anche fatto una lista. Poi mi sono lasciata andare all’improvvisazione, si adattava meglio a cambiamenti repentini e non calcolati come quelli che stanno caratterizzando questo periodo ben più esteso di 25 giorni. Ci sono io qua dentro? Chi lo sa. Ogni tanto penso stia diventando una sorta di terapia: psicologi e analisti in eventuale lettura, potete darmi il vostro parere, trovate un link contatti sul sito, potete scrivermi. In quanto tale, racconto mio intimo e personale, infarcito peraltro di fragilità, oggi sono anche arrivata a formulare l’idea che possa dare fastidio. “Ma tanto lo leggono di nascosto” mi fa notare un amico quando gli espongo i dubbi su questi eventuali lettori infastiditi e intenti a dipingere immagini pubbliche di sè più solide. Tant’è: ormai continuo, voglio vedere fino a che punto arriveremo, voglio registrare tutti questi giorni assurdi, siano 25 o 50. È un po’ come un’Amaca di Michele Serra – sì, lo so, ho fatto un paragone bestiale, mi perdoni Serra se sta leggendo -, dove ogni giorno inventarsi qualcosa cercando di non ripetersi. Io mi do gli spunti: le parole, le canzoni.
Oggi la parola che mi fulmina la trovo in uno spostamento in auto, mia madre al volante e io seduta dietro, questa strana modalità che ci dimentichiamo spesso di usare e che è assurda, ma pare obbligatoria. Insomma, il pomeriggio è grigio e siamo in auto, parte la canzone che darà senso alla giornata, e mi viene in mente la malinconia. Malinconia di un clima che non aiuta, per il tempo che passa nonostante tutto, per le occasioni perse, per le storie andate male, tempo gettato al vento che ha lasciato solchi di vita, certo, ma anche tante ferite.
Malinconia di progetti lasciati a metà, di anni in cui ad aprile ero a Roma, era tutto leggero, non c’erano i mostri in giro per strada. Mi viene una malinconia delicata e tuttavia gigantesca quando vedo le immagini delle Officine Grandi Riparazioni di Torino diventate ospedale da campo. È malinconia per il mio lavoro, che mai come oggi, davanti a queste foto, è stato così distante. Resto senza fiato: come sono cambiate le cose, come lo hanno fatto rapidamente, fuori da ogni controllo. Conosco benissimo quello spazio, penso al bus per arrivarci, alla conferenza stampa di inaugurazione col caschetto da ingegneri che faceva ridere, a tutti i colleghi, mi sento una nullità. Penso ai concerti che ho seguito alle Ogr, a una serata dove ho anche intervistato Paola Zoppi alla radio, lì, nella sala enorme delle Officine dove un tempo di facevano i treni, dove è passata tanta cultura, tanta spinta innovativa, e dove oggi ci sono letti di ospedale e trespoli per le flebo. Ho i brividi, sono scene che ripassano anche al telegiornale la sera, e non possono che farmi provare una malinconia abissale. Quanta distanza, quanto tempo, in soli due mesi.
«Non venite a prendervi della malinconia» dice nonna al telefono. Ha una voce che racconta un’altra giornata di malesseri e di ansie, di svogliatezza che le fa ripetere la bestialità del voler morire. Eravamo abbastanza distesi, tra gatti in caccia di cibo, rane appollaiate sui bordi della vasca delle ninfee, gambarossa da estirpare, prime fragoline selvatiche e le ultime fave da raccogliere. Sì, eravamo sereni, se così si può dire, ma la telefonata di nonna rompe l’equilibrio. È palpabile l’agitazione, l’avvilimento, il senso di impotenza. Nonna vuole il medico, non dà retta a nessuno, si domanda come sia possibile che nessun medico sia disponibile per lei. Vuole fare esami, magari andare anche in ospedale – ora, oggi, con la situazione che c’è, a 92 anni – per un fastidio che probabilmente è solo dato da una patologia psicologica, la famosa gastrite nervosa. Così ci andiamo, andiamo a trovarla.
Ed è nel percorso che passa una canzone in macchina, che vediamo un amico in strada e salutarlo dal finestrino apre il cuore quasi da commuovere, e in quel saluto con la mano e il sorriso a me sembra di cogliere una spinta vorticosa che grida alla normalità, che si affida al prima, che non sa come sarà dopo. Oggi ho letto una cosa che mi ha fatto riflettere sul profilo facebook di Simone Tempia. Spero di non fare torto a riportarla qui, ma mi è utile a riflettere su un altro mostro. Lui scrive: «Alla fine è arrivato. […] Si è insinuato tra un dito e l’altro, vicino alle dita sporche di pasta collosa, fino a raggiungere il braccio, la spalla, il collo. Certe idee, infatti, risalgono lente lungo il corpo prima di infilartisi dentro alla testa. “Sta vita qui la potrei fare anche per sempre”. Ho pensato. Mi son guardato le mani, ho chiuso l’acqua con il gomito. “In fondo non è poi così male”. Ho pensato di nuovo. Ed ecco che alla fine è arrivato. Quel pensiero lì. Quello che fa scomparire le cene, gli incontri, le chiacchiere, i desideri, i bisogni, le mancanze. Quello lì che non c’entra niente con la fase uno e la fase due. Quello lì che divide il prima e il dopo».
Gli ho risposto che è vero, che questa cosa è arrivata anche qui, aleggia per casa da giorni, sconquassa dentro come un dissennatore di Harry Potter: è capace di portare via tutto. Sto bene, tutto sommato, ho scritto a un’amica l’altro giorno, ma faccio sogni agitati, poi non me li ricordo ma al mattino sono distrutta. Nei sogni, credo di poter ricordare con vaghezza, ci sono alcune persone importanti, tutti quelli che sono spariti, di cui credevo di potermi fidare, i desideri, le felicità, le mancanze. Sono incubi, a tratti, che mi ricordano la distanza. Ed è una distanza che percepivo alle soglie del disastro pandemico, e di cui avevo paura. Sembra sempre, in qualche strano modo, che io navighi come sulla cresta di un’onda: vedo le cose prima, quando accadono però sono già oltre, è passato il momento. Insomma, questo pensiero che tutto sommato vada bene così, chiusa dentro la scatola di casa ad attendere Godot, mi sfiora spesso. Chiusi con me anche incontri, chiacchiere, desideri, bisogni e mancanze: danno spettacolo nei sogni, solo lì. Il resto è un ripiego di vita. È malinconico, questo pensiero, e mi spaventa, mi spaventa un sacco.
Eppure aleggia, tutto intorno. Eccolo, per esempio, nel silenzio di un sabato sera di aprile in centro: la passeggiata mare deserta non smette di angosciarmi. Strazia il cuore come poche altre immagini di questa città chiusa per pandemia. Il porto deserto con l’acqua liscia di cui spio un micro-angolo di sbieco, qualcuno ha messo la musica a volume alto, la scena è surreale e mette una malinconia abissale addosso. Malinconia delle passeggiate, anche se le facevo da sola. Malinconia della certezza che tutto funzionasse. Malinconia di una pizza in un locale sul porto, di una panchina e un gelato, di una foto a un tramonto che allarga il cuore.
La nonna è in crisi, neanche a dirlo. È in casa da 50 giorni, su per giù, e questo tedio in questi pochi metri quadri sempre uguali la sta distruggendo psicofisicamente. Spalanchiamo le finestre, cerchiamo di rallegrarla, ma segue il filo dei suoi pensieri che è egoistico al cento per cento. Riusciamo a farla ridere mentre si cambia, e si spoglia dai suoi mille strati di maglie e sottovesti, e io vedo una donnina fragile che però si porta dietro la pelle di una vita intera. È logorata dalla malinconia, mia nonna, e mi sa che l’indole caratteriale l’ho presa proprio qui, da lei.
«Ah sì?» dice quando le facciamo notare che la Regina Elisabetta, che sta a mezzo busto dritta e sveglia nel vestito verde smeraldo del suo discorso alla nazione, sul giornale poggiato sul tavolo di cucina, ha la sua età. Classe 1927, il filo di perle, lei, il foglio con i nostri numeri di telefono scritti cubitali, poggiato sul comodino, mia nonna. Non siamo in grado di pronosticare il futuro. Vorrei dirle che presto tornerà a vedere i suoi fiori, i gatti, ad assaporare un po’ di serenità. Ma chi lo sa? Dice che non ha le forze, io penso che se la bestia del virus la sfiora solo me la porta via. Dio, che situazione.
Piccoli passi, malinconici, ovviamente, un poco rassicurata dal fatto che si può sì, è anche giusto, sapere rinunciare alla perfezione. Ho dato la vernice protettiva a un mobile, ho lavato per terra in studio. Tutto perfettibile, tutto da fare meglio, con più convinzione e meno malinconia. Anche il lievito, che si è inacidito, ha bisogno di essere seguito con più attenzione. Non è un caso, mi dico, se dalle frequenze dell’autoradio oggi mi abbia colpita, con grande emozione, Costruire, di Niccolò Fabi:
Immagina una gioia
Molto probabilmente
Penseresti a una partenza
Di eccitazioni da prima volta
Quando tutto ti sorprende e
Nulla ti appartiene ancora
Leggi tutte le giornate del mio diario di quarantena: 25 giorni a casa.