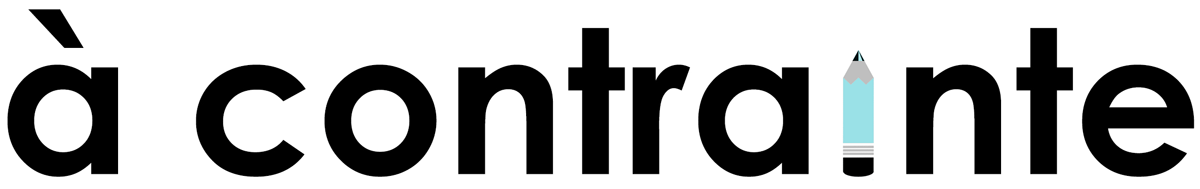Dunque è il quarantesimo giorno. Frase evangelica, frase simbolica: deserto, ristrettezze, fatica mentale, isolamento, pensiero teso al futuro. Tutto, più o meno, così. Se non che ormai forse è la routine e mi sto abituando – ci stiamo abituando -, se non che nel mio piccolo mondo da cui non mi sposto non è tutto completamente deserto. Oggi sono quaranta giorni esatti da che il governo ci ha chiesto di restare a casa perché è in corso una pandemia. E lo so sto scrivendo eh, badate bene che lo sto scrivendo su un diario che racconta la realtà, non in un testo di fantascienza. Lo scrivo perché resti, perché nel futuro io possa girarmi indietro e capire com’era, e com’ero io, come eravamo tutti. Per ricordarmi di cosa successe, in questo tempo che è tutto uguale, da quaranta giorni, nonostante l’avvicendarsi delle stagioni, l’ora legale, la luce e le gemme che esplodono nel verde nuovo che non vedremo.
Il lievito, intanto, è ancora vivo: la torta è gonfiata, profumo di pasticceria in casa. Chissà i vicini se lo sentono, sono anni che cucino e che diffondo aromi a tutte le ore del giorno e della notte. Ieri ho scritto una cosa sui vicini, li ho trasformati, ho accorpato pezzi di vite, li ho estremizzati. Stamane mentre scrivo recensioni mi passano davanti, davanti alla porta da cui io vedo e loro no. E penso che mi sento chiusa qua dentro, in questa bolla, che non ho rapporti col mondo se non per via scritta, via telefono. Ma che non è la stessa cosa. Inizia a pungere, lembi che si staccano, abitudini che si cristallizzano e bisogna che non restino così, perché non vanno bene, perché sono sbagliate.
Le etichette. Oggi rifletto sulle etichette. Mi arrabbio, sulle etichette. Ne trovo una inaspettata su di me. Mi descrive, sì, ma solo per un dieci per cento: non ha tenuto conto di tutto il resto. E tutto il resto dove è finito? Perché non c’è? Bella domanda. Mi rotola nei pensieri e accelera, accelera, si prende tutto lei, come quando fai un impasto e cerchi di far assorbire tutta la farina. Una palla vischiosa dove si mescola tutto: svilimenti, denigrazioni, fallimenti, scelte non fatte, scelte sbagliate, soluzioni di comodo, paure – uh, le paure -, credenze. Continuo a dirmi che sta tutto in un problema di comunicazione, che poi sarebbe anche la mia materia, il mio lavoro: qualcosa deve essere andato storto nel processo se io sono x e viene comunicato e manifestato y, senza che di x si immagini anche solo in remoto l’esistenza.
E quindi via con il lavorio terribile: quando è successo, perché è accaduto, in quale bivio sbagliato ha iniziato ad accumularsi questa cosa falsata? Dove si è perso il buono, il materiale da costruzione che dopo anni non ha costruito proprio niente? Un logorio. Pesante, opprimente. Porterebbe ai matti se non potessi sfogarmi, e chi riceve lo sfogo ha la pazienza di aiutarmi a raccogliere le tessere, farmi vedere come avrebbero potuto essere incastrate, e come non lo sono state. C’è naturalmente un perché dietro a questo disegno che poteva essere così ed è stato cosà. Tutto sta nell’accettarlo, perché è lì che punge, è lì che spinge al muro e fa rivedere caratteri, priorità, idee e passi indietro. E io non lo so se lo accetto, se mi sta bene, se forse vorrei cambiare. Per diventare cosa, se poi non mi piacerebbe ciò che penso, faccio, le cause profonde per cui lo faccio?
È tutto colloso, un mondo che è una bolla dove riuscire a destreggiarsi senza istruzioni. Intuire, assaporare l’aria con vibrisse che devono imparare da sole ad allenarsi. Ci vuole un ego spropositato, e io non ce l’ho, non ce l’ho mai avuto. Ho più dimestichezza con la vergogna dello sbaglio, il rifugio dagli occhi del mondo che giudica e ti etichetta. Così abituata a dover essere etichettata, che se quel riferimento manca non trovo più un senso. Quello che resta è scorporato, non ha consistenza, non ha progetto. Aleggia. E se aprissimo una libreria? Io ci sono, ti scrive provocatoriamente un amico. E se, e se, e se. Quante volte ci ho provato. Quante idee, schiantate contro i muri di reti di cui non faccio parte. A me tutta sta finzione ha schiacciato l’anima, non ce la faccio più: ma perché non ci diciamo come stanno le cose? Perché non ci diciamo delle collaborazioni gratuite fatte solo perché fa figo avere il nome lì? Della pochezza di tanti, dei problemi dentro cui sbatti come in muro di gomma e l’unica, la più facile, è la storia dei sorrisi falsi mentre dentro ti muoiono le idee? Non è così? Forse è l’altra storia, quella dei passi lunghi due volte le gambe, che bisogna avere fegato per farli, eccome, bisogna avere un ego sfrontato, sicurezze di ghisa, sguardo alto. No, non è roba per me.
L’umore raggiunge i minimi termini. Mi perdo in ciance: file aperti, cose da fare che si sfilacciano e non hanno più importanza nel momento in cui la concentrazione è tutta lì, un riflettore puntato sulla protagonista unica, un corpo disperato in mezzo al palco, si stringe a sé, no sa che altro fare al momento. Nemmeno a farlo apposta, arriva un deus ex machina sulla mail. Roba da colpo di teatro, neanche a sognarlo.
Ci si rimette in gioco, tutto improvvisato, tutto nel giro di un paio di ore, con un po’ di agitazione, ma nemmeno troppa, e con il solito bagaglio di punti interrogativi per ogni occasione. Improvvisamente, nel non sapere, si aprono scenari, il futuro si allarga. È ignoto, ma diventa presenza, e questa cosa è già una conquista, fa portare vittoriosi la giornata a casa. Mi rendo conto di questa montagna russa che non lascia scampo: a terra i cadaveri delle cose che avrei dovuto fare. Continuo a non spiegarmi perché, in giornate dove non ho niente da fare, io riesca a essere indietro con le cose che devo fare. In ogni caso, anche oggi l’abbiamo sfangata, per un pelo, è vero. Con nuove illusioni e cadute all’orizzonte.
Oggi mi è arrivata la newsletter della Lettura del Corriere, c’è dentro un testo di Francesco Piccolo che racconta del suo diario della quarantena e, a discapito del “fastidio” che la scrittura di sé, dentro i propri intarsi mentali, possa dare ad alcuni, lui consiglia di scrivere un diario, anzi dice proprio che è cosa buona, è utile e tutti dovrebbero farlo. Ora, io non lo so se è buono o no, se il filtro narrativo che frappone questi fatti veri che digito sulla tastiera spesso in modo sciatto, altre volte in giri di frasi più ragionati, possa essere utile in primo luogo a me o a chi legge. So però che da quaranta giorni porto avanti un piccolo grande compito come quello di scrivere una paginetta o poco più. Tutti i giorni, con dentro una parola intorno su cui soffermarsi a riflettere, con dentro una canzone vecchia o nuova il cui testo mi dice qualcosa del mondo. Sono tutte contraintes: un testo al giorno, anche se sei stanco e non hai idee, una parola da trovare – e a volte, voi non lo sapete ma è così, ci penso dal mattino, a volte riesce spontanea e capita dai fatti, a volte no: in questo è come le notizie quando lavoravo al giornale, giorni in cui ne hai troppe, giorni in cui chi lo sa, aspettiamo i fatti – una canzone e una foto. C’è molta improvvisazione, lo confesso, ma è ragionata ogni giorno. Improvvisare ragionando ha un senso? Non saprei, forse ha più a che fare con armonie depositate da qualche parte, e con l’intuito.
Gira in testa da ieri, parla di prendere rischi, e allora oggi è perfetta: Adele, He won’t go0
I won’t rise until this battle’s won
My dignity is become undone
I can’t do it on my own
Leggi tutte le giornate del mio diario di quarantena: 25 giorni a casa.