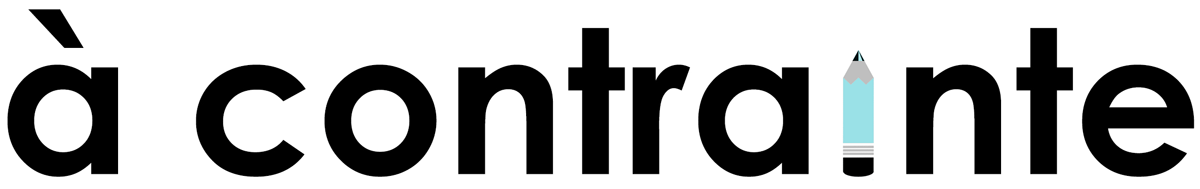È il 16 aprile 2020, il giorno numero 39 della mia quarantena, un giovedì. Impasto il pane, impasto un dolce, bevo il caffè. Faccio per andare giù in studio a lavorare – questo nuovo e insolito concetto di lavoro – e scopro che è morto Luis Sepúlveda. Questa sarà la notizia del giorno, l’irrealtà moltiplicata sulla bacheca di Facebook, ascoltata in radio, al telegiornale. Morto di Coronavirus. Sarebbe stato a mille festival, ma è proprio a un festival che, pare, si è ammalato. Il pensiero va al Salone: quante volte l’ho visto, quante ne ho sentito parlare.
Nella mensola dei libri della mia infanzia e adolescenza ci sono tutti i capisaldi: c’è anche Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. Scorro col dito i dorsi, li so più o meno a memoria: Pitzorno, Rodari, Durrell, Benni, Pirandello, Svevo… Sepúlveda. La Gabbianella, edizione 1997, le pagine sono ingiallite. Il vecchio che leggeva romanzi d’amore, copertina anonima, anche lui devo averlo comprato dalla signora della libreria La Talpa: era nelle letture estive consigliate dal mio professore di filosofia. La Gabbianella, invece, era un consiglio di lettura arrivato sul finire della quinta elementare, me lo ricordo nitidamente. Mi ricordo la maestra Giovanna, il suo sorriso, la tenerezza di questa storia. Mi ricordo di quando l’ho vista al cinema, e dopo tanti anni di oblio l’ho riletta prima di prendere un aereo, perché c’era un gatto che si era ripromesso di insegnarmi a volare.
Coinvolgo i compagni di classe: ma voi ve lo ricordate? Era la quinta, vero? Il libro uscì nel 1996, in estate, non poteva essere la quarta, era quinta, ma sì, ma sì l’edizione che ho io è di maggio 1997, e la scuola era quasi finita, mi ricordo la pizzata di classe, lettere imbarazzanti, giochi di bambini, consigli di futuri adolescenti ingenui. La semplicità, che già si faceva complessa. I problemi banali che riempivano l’universo. Si volava con poco.
Si è continuato a volare, anche se le difficoltà crescevano, come è normale. Parte il nastro dei ricordi, va all’indietro. Le letture delle elementari, quei lavori bellissimi tra Marcovaldo, Rafè e Micropiede, L’occhio del lupo che, ora è chiaro, sono le basi su cui sono diventata una lettrice. Grazie, maestra Giovanna, e grazie anche maestra Marilena, con le gare di matematica dove Simone Fabio e io ci scapicollavamo fuori dal banco per consegnare per primi e vincere il premio.
Ne parlavo l’altra sera coi miei: non ho capito che tipo di intelligenza ho. Quella creativa forse prevale, ma quella logico-scientifica non l’ho mai abbandonata, ne sono testimonianza le pagelle del liceo. E scattano, naturalmente, i ricordi del liceo, perché dietro la schiena ho a guardia l’IL e un Rocci, e i volumi verde bosco della letteratura greca di Guidorizzi, e so di non sapere più niente, ma so anche che da qualche parte c’è tutto scritto, c’è l’impronta, ci sono io.
Mi arriva dallo schermo anche la faccia di Michael Stipe, la voce, It’s the end of the world as we know it? No, è solo un momento di pausa, una specie di occasione rara e preziosa. Questo dice lui dal suo sottoscala made in USA, e racconta di amare l’Italia. Mi viene in mente il concerto dei Rem all’arena di Verona: una vita fa, il cuore pulsante dei miei vent’anni. Sono di nuovo nel passato, oggi sono proprio voltata indietro che cerco, mi riscopro, ritrovo momenti, chiavi, nodi. Oggi la parola chiave è proprio questa: il passato.
La musica dei Rem è uno di questi, è un mattoncino di me, anche se oggi non risuona più come allora, come quelle sere d’estate abbracciandosi le ginocchia davanti a un vecchio cellulare e agli sms, come su quei balconcini al sole della primavera torinese, su quell’intercity che viaggiava per Milano e di cui da qualche parte ho ancora delle foto, o come quel poster lasciato in albergo per sbaglio con un uniposca costato un patrimonio. Avevo la maglietta azzurra dell’Hard Rock Cafè di Oslo e i bermuda, ero molto più magra, non avevo il ciuffo bianco tra i capelli, le rughe intorno agli occhi, il cinismo devastante che ho addosso, le paure che alimentano il mio motore fermo. Sembrava tutto possibile.
Scorro qualche foto, ritrovo anche quella che chiamo la foto dell’aquilone. Ci siamo io e il mio amico con cui oggi scambio un ping pong di messaggi sul come saremo domani, chi saremo nel futuro: due adulti, quelli che impersoniamo già oggi. Nella foto camminiamo in una serata primaverile torinese, e sembra una vita fa, sembra una cosa che ha smesso di riguardarmi ma che, come le letture, come le canzoni, ha lasciato un’impronta e oggi è un mattoncino della mia casa interiore. Sono io: nelle pagine, nelle canzoni, in piazza Castello dopo una giornata di lezione.
Il futuro non era niente di così spaventoso, allora. Era un dato scontato: sarebbe arrivato, qualcosa sarebbe accaduto. Forse nemmeno ci pensavo, questo piombo non rientrava nei miei pensieri. Questo piombo che oggi invece devo ammansire, e mi metto a scrivere, a progettare. Le idee sono così tante e richiedono tutte così tanto sforzo creativo – e speranza – che ne inizio tante, spizzico qua e là per ciascuna, la giornata procede, alla fine sono le otto passate, ed è ormai buio quando arrivo alla parola fine, salvo il file, chiudo.
Ma è chiaro che siamo
I biscotti inzuppati nel latte
Con i discorsi dopo mezzanotte
E ci ridiamo ancora
Ci piangiamo ancora qua
Leggi tutte le giornate del mio diario di quarantena: 25 giorni a casa.