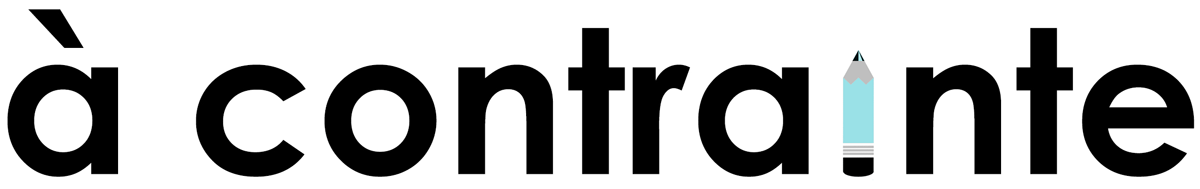Questo, teoricamente, giorno 55 della quarantena, sarà l’ultimo sabato costretti a casa, l’ultimo prima della fase2, per lo meno. Come consuetudine, quella che ci portiamo dietro come una copertina di Linus dai primi di marzo, quando ancora era inverno, veniva buio presto e indossavo il cappotto, mi sveglio e impasto la pizza per sta sera. La pizza che viene buona, col sugo dei pomodori dell’orto, oggi con un lievito di birra scaduto, perché sì, a casa mia è anche successo che in tempo di scarsità di lievito ne facessimo scadere uno – questo dà l’idea dell’attenzione e precisione con cui abbiamo seguito le cose durante la quarantena. Ma dicevo: la pizza che mangeremo con la birra. La pizza che è buona eh, per carità, ma a me quella della pizzeria inizia a mancare tanto che me la sento col suo sapore e la crosta croccante proprio sulla lingua, mi viene l’acquolina.
Se mi domando che fine ha fatto tutto quello che prima era nornale e che davo per scontato, tipo uscire una sera con gli amici a mangiare una pizza, mi sembra una consuetudine remota. È mai esistito? L’ho mai vissuto? Ma poi, soprattutto, tornerà? Perché io avevo delle persone con cui parlare, dei sorrisi da fare, delle occhiate da lanciare. E tanti progetti. Una vita, con le sue routine. La parola di oggi è routine, una parola che non è nemmeno italiana. «Modo, ritmo di vita e di attività che si ripete giorno per giorno, sostanzialmente immutato, con senso di monotonia» mi dice il dizionario Treccani online. Questa connotazione di monotonia, secondo me, è vacillante. Perché sì, sono sincera: ora, al giorno 55, l’ennesimo sabato consecutivo, da febbraio, in cui non vedo nessuno – l’ultimo sabato umano che ricordo si è concluso con un pacco e una fuga a casa per una conferenza stampa straordinaria -, la routine è oltre la monotonia, è malattia.
Mi piacerebbe che da lunedì tornasse non dico tutto uguale, ma almeno un tempo scandito, una nuova routine, ché questa della sedicente libertà di leggere e disporre del proprio tempo mi ha stufato. Succede che all’improvviso voglio il lavoro, voglio le ore in cui non vedo l’ora di finire perché dopo posso fare altro. Tipo uscire, andare a vedere il mare, respirare quel che resta del profumo dei fiori di pitosforo, anche se è tardi, e sono già sfioriti, tocca aspettare un altro anno intero. Questo senso delle cose perse. Questo senso del tempo sbriciolato, delle cose che potevano essere. Penso, rifletto e scrivo da mesi, ormai. Nel mezzo non vivo. E tutti a parlare delle coppie, dagli amanti ai fidanzati. Io son qui senza un amico, con quelli vicini che si sono stretti via internet, quelli lontani che sono ancora più lontani, e questo è uno de più grandi cambiamenti di una pandemia inaspettata.
E son qui con una moleskine dalle grandi promesse di inizio anno, che è rimasta ferma e immobile perché all’improvviso di quel tramestio che dava linfa alle domande non c’è rimasto nemmeno più il presupposto. Tutti a casa, in qualsiasi senso possibile. A casa è tutto più sicuro. Ci sono voluti 55 giorni per farmi tornare il dubbio che forse no. E ora chi lo sa. Ora tocca uscire dalla tana e vedere che sarà. Tocca riprovarci, spezzare la routine e salire in giostra. Me lo suggeriscono tanti segnali, ma più che altro L’ultima intervista, il libro di Eshkol Nevo che sto leggendo e che mi tiene incollata il pomeriggio, il solito gradino di ardesia ma la luce oggi è già cambiata, è la luce di maggio, l’aprile dolce è trascorso e ora è tempo di sole che picchia, erba alta e delle prime zanzare tigre.
La natura è implacabile e continua a fregarsene: cresce una cipolla nell’aiuola sotto casa, in mezzo ai rovi, e la fragola matura è morsa da un colombaccio, e le rane sono otto, diventano grandi, concertano ad alto volume mentre si risvegliano gli insetti, sentono il caldo, forse non ne possono più nemmeno loro e tornano a darci il tormento. Come la routine, quella che mi dà spesso il tormento, quella a cui cerco nonostante tutto di aggrapparmi ora, per darmi un ritmo, un senso, per ricordarmi che non esiste solo questa specie di sottovita da appartamento, che c’era altro, nella mia pur ristretta esistenza.
Anche oggi ho scritto, ho inviato un racconto, ne ho impostato un altro, è uscita una mia intervista su Riviera Time. Sembra che tutto vada avanti, e forse questa lancetta che mi ha portata a maggio è scattata, anche se la mia testa è rimasta là, a febbraio, quando era tutto una promessa e poi non so bene come e quando è cambiato il mondo. Oggi è il penultimo giorno, c’è elettricità nell’aria, si aspetta lunedì. Le forze sono esaurite, la routine è diventata incubo. Il lavoro, il lavoro che sarà, che potrebbe diventare: dare un senso, trovare uno scopo, andare verso una direzione. Questo, credo, è quel che vogliamo tutti. Perché c’è davvero un limite grande a tutto questo letargo imposto dall’alto, da un virus, dalla paura. Non ho le idee molte chiare sul dopo, ma è scattato qualcosa, oggi, che mi invita ad andare. Speriamo bene.
Scrivo con la radio accesa stamane e passa un sound noto. Sono i Simply Red, Sweet child:
I see tears where there should be joy
For every little girl
And every little boy
A desert that needs some rain
To help you out and ease your pain
For every little girl
And every little boy
A desert that needs some rain
To help you out and ease your pain
Leggi tutte le giornate del mio diario di quarantena: 25 giorni a casa.