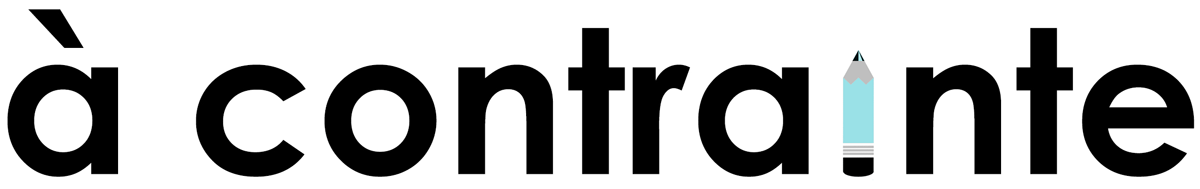Non sono esperta di letteratura nordica, ma dopo aver letto qualcosina grazie alle splendide pubblicazioni di Iperborea, devo ammettere di aver fissato qualche punto. Uno di questi è l’Islanda di Jón Kalman Stefánsson, la sua geografia, i paesaggi, i colori, e la lingua che li accarezza per descriverli, riportandoli ai miei occhi che dentro hanno solo il Mediterraneo e dipingendo quadri sferzati di azzurro, freddo e aringhe. Ecco perché quando ho letto Isola, di Siri Ranva Hjelm Jacobsen, ho pensato subito a lui, a Stefánsson, e alla poesia del suo linguaggio. L’aspetto che infatti metterei in luce per primo di questo bellissimo romanzo è proprio la poesia della lingua, che richiama i paesaggi di Stefánsson, e che mescola colori, suggestioni, venti e atmosfere che parlano al lettore del Grande Nord. Non si può prescindere dalle meravigliose immagini di colori e sensazioni che l’autrice ricama in queste pagine: sarebbe come perdere più della metà della bellezza di questo romanzo, che è anche racconto di una geografia, di un luogo.
Quando mi svegliai, un azzurro luminoso aveva cancellato le differenze tra gli elementi. Una trapunta d’azzurro era distesa sui pescherecci. Sulle navi da crociera più in là. L’azzurro era infinito e morbido. Mi ci persi dentro. Allungai una mano, era azzurra. Tremava
Siri Ranva Hjelm Jacobsen racconta le sue isole, le Isole Faroe. Siamo nel grande nord, tra il Mare di Norvegia e l’Oceano Atlantico, eppure siamo in un territorio danese. La storia di questo posto, che sono andata a riscoprire presa dalla curiosità, è straordinaria. Isole verdi, di pecore, di aria e di mare, di lardo di balena e aringhe, isole che fieramente hanno combattuto per l’indipendenza, tanto da avere un governo autonomo. Hanno anche una lingua propria, il faroese, che rientra infatti tra gli elementi significativi nel viaggio della nostra narratrice a ritroso nel tempo e alla riscoperta di uno spazio che le appartiene pur senza coinvolgere direttamente la sua vita, che si svolge altrove e approda alle Faroe solo in parentesi, momenti di ritorno a un luogo da cui in verità non è mai partita, non essendovi nata.
Pensai a Itaca, l’isola alla fine del viaggio. Non allora, ma adesso. Adesso che ero qui: in fondo al fiordo di Sørvágur, con il villaggio dietro di me e la vista su Mykines. Le mie suole affondavano un po’ nella sabbia
La protagonista ritorna alle Faroe dopo la morte della nonna, che chiamerà per tutto il libro col nome affettuoso in lingua, omma (il nonno è invece abbi), e ricordando la figura a lei cara inaugura un viaggio che è anche un interrogativo sulla propria identità di migrante. Lei, nata a Copenaghen e danese, sente di appartenere in qualche modo a quell’arcipelago remoto che diede i natali ai suoi nonni, nonni stessi primi migranti da una terra che poco offriva a uno sviluppo economico (pesca, aringhe sotto sale, merluzzo). Ma che cos’è casa? Isole distanti con cui, volente o nolente, poco si condivide, a partire dalla lingua stessa, un faroese stentato e parlato con accento danese tanto da dichiarare subito la sua finzione. Isole vissute solo nell’estate delle vacanze e nei weekend, quasi come turisti in visita consapevoli di un ritorno già segnato.
Si fanno tanti discorsi, su cosa sia casa. Uno stato d’animo, le persone che s’incontrano, roba del genere. Per me erano solenni stronzate. Roba da cosmopoliti con lo zaino in spalla, che parlano con la bocca piena di terra, piena di carne. Che vanno in giro a masticare il mondo. Casa è un toponimo, pensavo. Un nome geografico
C’è un elemento ricorrente insieme alla lingua poetica, agli azzurri e alla luce del paesaggio, ed è la malinconia, che è come impastata nel paesaggio stesso e nella storia del nonno, tenacemente ancorato ai propri luoghi, eppure tenuto distante, alla costante ricerca di un modo per tornare a Itaca, Ulisse moderno solo più rassegnato ai fatti, assoggettato dagli eventi.
Quello che è certo è che viveva nel futuro, finché non ha cominciato a vivere nel passato. In questo senso era un vero migrante
Isola è, a suo modo, un libro sulla migrazione narrata da colei che appartiene alla terza generazione e che forse è sufficientemente distante dall’origine dell’allontanamento per dire qualcosa di nuovo, qualcosa in più. La protagonista riflette, torna nei luoghi dell’infanzia, degli affetti e della famiglia, e non smette di andare avanti e indietro nel tempo, di passeggiare osservando, di immergersi nei colori e nelle atmosfere ricordando la magia delle saghe raccontate e riportandola alla schiettezza dell’oggi. Dipinge un intero mondo, un mondo particolare come solo quello di queste isole remote sa essere: verde, pieno solo di pecore e mare, e attese sull’orizzonte delle isole, e poi tunnel, ponti, collegamenti in traghetto. Un universo spezzettato e tutto unito, come un’esistenza frastagliata, divisa tra una patria e un’altra, alla quale costruire un ponte che faccia da passerella.
La migrazione si compie in tre generazioni. La prima avverte il bisogno e porta in sé la volontà, l’ostinazione: una pietra pesante che si porta con le proprie forze. L’incomprensibile in questo. […] La generazione successiva forse sta a gambe divaricate sulla distanza, finché qualcosa s’incrina e allora si sente doppiamente sbagliata, senza nessuna lingua, doppiamente sola. […] La terza generazione può permettersi lavori poco lucrativi, deve esprimere la propria interiorità, trasportare di qua anche lo spirito, credendo che sia questa la realizzazione di sé. La radici trepidano e frugano. Portano particelle morte di un’altra terra. La terza generazione è una coperta troppo corta, porta il viaggio dentro come una perdita, per metà padroneggia e per metà no, invisibile e teorica.
Intorno a paesaggi mozzafiato, nelle pagine di Isola è prepotente la ricerca interiore di una trentenne di oggi, motivo che me l’ha resa così familiare e amica. Una ragazza pienamente consapevole dei sacrifici del passato, che saltando la generazione dei genitori sa leggere la malinconia del nonno e, non condividendo però la nascita in quel luogo, sa rifletterla, farla propria e cullarla, sentirne il sapore nel cibo della festa di San Giovanni, leggerne la piega nostalgica, capirne il valore profondo rievocando la storia del masso sotto cui si nasconderebbe una creatura magica dei boschi, leggenda nordica.
Uscii a camminare per le strade in pendenza. La città, come nelle notti feriali in provincia, faceva la quinta a quello che avevo in testa, cartacea e bidimensionale, una tela su cui mi spiaccicavo.
Non c’è una soluzione a questa ricerca che è insieme generazionale, geografica, squisitamente personale nei richiami autobiografici dell’autrice, eppure anche universale, mai quanto oggi, nello scorrere di fiumi e fiumi di discorsi imperniati sul tema delle migrazioni. Ma è dolce l’affetto di una nipote lontana, che non smette di arrovellarsi, e che è come chiamata dal paesaggio stesso, un posto così estremo, verde e magico da risultare quasi magnetico, da evocare sempre e ancora una malinconia sfuggente come il fantasma di un’isola all’orizzonte lungo il fiordo. Ecco perché allora la narratrice si domanda come sarebbe stata la propria vita se invece che in Danimarca fosse nata alla Faroe:
Sarei scresciuta con un panorama più bello, con più verde, più Gesù, meno lesbiche, molte pecore e nessuna nostalgia patologica. L’ultima era la cosa più importante.