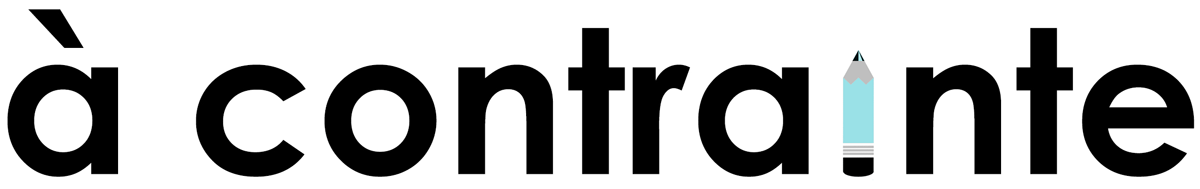È il 2022, febbraio sta finendo ed è scoppiata la guerra. Non per metafora, non in un posto lontano da casa – l’Europa, per me – ma qui a due passi, un’invasione che semina angoscia tra le coscienze, orrore nelle immagini e la cui eco suona come un sinistro “terza guerra mondiale”.
Non sono giorni facili, sono piuttosto collosi di angoscia per eventi che sembrano sfuggire al controllo razionale, al senso che potevamo esser certi di attribuire alla realtà. Lo sono per i racconti dei telegiornali che riattivano conoscenze scolastiche della geopolitica e fanno tremare. Catene causali, catene di auto in fuga, treni assaltati e i fucili, i missili, i messaggi, i morti. La disperazione, i confini, i pianti e l’incertezza che domina sovrana sull’est Europa e su tutti noi.
Non lo so cos’è la guerra, non l’ho mai vissuta. Ipocritamente non penso con questa tonante paura nel petto all’Afghanistan, alla Siria, all’Africa, ma sono nata tre anni prima della caduta del Muro di Berlino e casa mia, l’Europa, una guerra in questi 35 anni non l’hai mai sperimentata.

La guerra che sarà
Incollata e al tempo stesso lontana dagli schermi onnipresenti che, oggi, ci raccontano in diretta la costernazione e il sangue, la paura e le dichiarazioni dei governi, da giorni cerco di gestire e tenere insieme la complessità che mi sconvolge. Mi manca il lessico della guerra, anche se so che da qualche parte ne conservo memoria arcaica: emerge quando cerco di interpretare, di figurarmi quel che accade e proiettarlo nel domani per provare a immaginare quel che sarà. Non ho mezzi per saperlo, se non la logica, i commenti dei giornalisti e i racconti che mi hanno lasciato i miei nonni, che vanno mescolandosi a un dono prezioso lasciato dai libri. Le mie memorie di una guerra mai vissuta: il mio modo per conoscere, dire, pensare e provare la guerra. Finché non è scoppiata sullo schermo della televisione di casa.
Ecco, in questi giorni bui e pieni di opprimenti interrogativi, non riesco a non tornare con la mente alle parole dei quattro ambasciatori del mio mondo di letture classiche. Sono approdata qui: Ginzburg, Calvino, Levi, Pavese. Quattro scrittori che mi hanno raccontato la guerra, e da cui ho saputo qualcosa di più: con loro ho avuto paura, ho visto cos’è un bombardamento su Torino, cosa significa la guerra civile, com’è la vita, come cerca di proseguire, quando intorno tutto smette di essere “normale”.
Sono quattro nomi italiani del secolo scorso, quel Novecento lacerato da due guerre mondiali che sentivamo ormai alle spalle, il secolo in cui sono nata, figlia dei miei genitori boomer, a loro volta messi al mondo da chi la guerra l’aveva vissuta sulla pelle, con perdite, lutti, ferocia e ingiustizia. Quel seme è rimasto da qualche parte nel mio DNA: nei discorsi commossi che faceva mia nonna, nei silenzi con gli occhi pieni di lacrime, che solo il tempo trascorso e le rose del giardino al sole di un nuovo giorno di pace sapevano accarezzare.
Mentre stiamo qui a guardare
La memoria, mi sono sempre ripetuta: devo serbare la memoria. Penso a mia nonna, alla quale – forse per fortuna – tutto questo nuovo dolore da rivivere è risparmiato. Adesso è quest’epoca di nuova angoscia, la storia che si ripete, le lacrime che tornano, il cuore che batte nel petto, l’oppressione di ingiustizia e follia inarginabile, il sangue, la polvere, i cannoni, le minacce che soffocano ogni orizzonte di speranza. È la realtà che lacera tutto, non sono parole di inchiostro. Eppure quanto preziose sono ancora, oggi, quelle parole per aiutarmi a dare un senso a tutto.
Mentre stiamo qui a guardare non posso fare a meno di farmi aiutare dai libri: non certo per capire le dinamiche del conflitto, nemmeno per commentare le scelte politiche. Sono un’umanista: dai libri cerco parole per capire comportamenti, emozioni e umanità. Cerco esempi, lacerti di vite che vivono scene analoghe a quelle che vedono in tv, che hanno paura, che devono scegliere, che sbagliano, fuggono, si disperano, e sperano. Me le faccio raccontare, cerco di capire.
Nell’edizione 2020 di Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino è stato incluso un racconto inedito. Si intitola Flirt prima di battersi, è del 1947 e racconta la vicenda di un ragazzo che, sospeso tra privilegio borghese e impegno politico, non sa dichiarare alla propria fidanzata la volontà di partire per la montagna, di unirsi alla Resistenza. Impaurito, insicuro e un po’ ipocrita, poco convinto, lo vediamo su uno sfondo che viene facile associare alla Sanremo di allora. Estate, lungomare Imperatrice, con le sue sontuose palme e la memoria incisa della bell’epoque, quando sul corso passeggiava anche la zarina. I russi a Sanremo sono stati una presenza massiccia e di loro segni è piena la città: la chiesa ortodossa, i grandi alberghi, il nome stesso della passeggiata Imperatrice.
Sanremo era terra di vacanze e clima piacevole, una panacea per la grande nobiltà europea che qui svernava e che diede avvio al turismo balneare. Ecco perché stride questa scena del racconto di Calvino alla quale mi è venuto da pensare associando russi, guerra e fine della pace che avevamo creduto di poter gestire, tutti. C’è la guerra, Sanremo è una cittadina sul mare, ma il turismo nobile è sparito. Via i verdeggianti lungomare, le ville, le dame a passeggio: c’è la guerra, tutto è solo, nero, tutto è morte.
Sulla spiaggia in corpi fermentavano di sole e di noia. Era un’estate morta, per i bagni: le spiagge abbandonate, ingombre di costruzioni antisbarco, il mare nero minato tutt’intorno, la sabbia trascurata, sporca come terra. Nessun bagnante venuto da fuori: solo soldati tedeschi dal corpo bianco e carnoso, con mutande ridicole
Nel buio del coprifuoco
Sta succedendo di nuovo, ed è assurdo. Seguo i racconti di Francesca Mannocchi, sempre più tesi, e non posso non pensare alle parole del mio professore di linguaggio giornalistico, Mimmo Càndito, reporter di guerra che nel suo libro I reporter di guerra raccontava con dettaglio e umanità i tanti conflitti seguiti nel corpo a corpo che l’informazione da sempre porta avanti nel campo più complesso e rischioso che c’è. Tuttavia, per quanto emozionante e appassionante sia questa narrazione, è un racconto di chi ha scelto di essere sul fronte di guerra, e ha qualche piccolo privilegio rispetto ai civili.
Perché quello che strazia delle immagini di questi giorni è constatare cosa sia piombato addosso da un giorno all’altro a tutti quei civili come me, come noi (sono un’ipocrita occidentale europea, se penso alla Siria è più evidente che mai), gente che fugge in macchina verso autostrade e non a piedi in mezzo al deserto. Gente che, probabilmente, vedeva un futuro. Non ho potuto non ricordare una scena del Primo Levi di Il sistema periodico.
Torino è sotto attacco e vige il coprifuoco, ma prima del 1941 Primo Levi può ancora andare all’università e frequentare i corsi di chimica. Più difficile risulta trovare un relatore per la tesi di un ebreo, e infatti il giovane Levi fa fatica:
Incassato compostamente il quarto o quinto rifiuto, stavo rincasando una sera, in bicicletta, con addosso una cappa quasi tangibile di scoramento e amarezza. Risalivo svogliatamente via Valperga Caluso, mentre dal Valentino giungevano e mi sorpassavano folate di nebbia gelida; era ormai notte, e la luce dei lampioni, mascherati di violetto per l’oscuramento, non riusciva a prevalere sulla foschia e sulle tenebre. I passanti erano rari e frettolosi
Nella Torino buia dei bombardamenti, lo studente incontra un assistente volenteroso che gli permette di entrare all’Istituto di Fisica Sperimentale. Levi entra in un ambiente pieno di polvere e fantasmi secolari ridotto così dai bombardamenti. L’assistente lavora in questo posto che sta in piedi per miracolo, dove non è possibile restaurare né acquistare nulla di nuovo, dove si vive nel presente delle poche possibilità, e il futuro si è improvvisamente rarefatto, svanito tra macerie e resti di una vita precedente.
E non c’era più nessuno che potesse far finta di niente
Sono stata al Polo del Novecento di Torino, anni fa, e ho partecipato alla simulazione in realtà aumentata di un bombardamento. È stato lì che ho conosciuto Bruno Segre, ho ascoltato il racconto della sua laurea a Torino con Luigi Einaudi e della notte dei primi bombardamenti sulla città, nel giugno del 1940, delle fughe nel rifugio sotto i palazzi. Ci sono stata, in quei rifugi: guide vestite da personale dell’Unpa simulavano un allarme bombardamenti facendo ruotare la sirena antiaerea. Quel suono sinistro mi è entrato nelle ossa: l’ho risentito pochi giorni fa in televisione.
E mi è tornato in mente quel momento, il giovane ricercatore che prendeva in prestito le parole di Pavese per raccontare a noi giornalisti la Torino dei bombardamenti. Siamo in La casa in collina, è estate e le persone scappano dalla città salendo la collina per cercare rifugio e salvezza dai bombardamenti notturni. Mi si è fissata in testa l’immagine delle persone col materasso sulla bicicletta, in fuga dalla “città condannata”, dai “terrori imminenti”.
Ci salivo la sera come se anch’io fuggissi il soprassalto notturno degli allarmi, e le strade formicolavano di gente, povera gente che sfollava a dormire magari nei prati, portandosi il materasso sulla bicicletta o sulle spalle, vociando e discutendo, indocile, credula e divertita. Si prendeva la salita, e ciascuno parlava della città condannata, della notte e dei terrori imminenti.
Se ancora non avessi colto tutto il potere delle parole di Pavese, e dei suoi colleghi, basterebbero anche solo poche righe del suo romanzo associate alle immagini di questi giorni per dare vita a un cortocircuito parlante. Chissà cosa penserebbero i miei nonni, e i “miei” autori novecenteschi davanti a questa pagina di storia che ci apprestiamo a scrivere vivendola come loro hanno vissuto la seconda guerra mondiale. Saprebbero raccontarci molte cose sulla paura, sulla morte e sull’amore, sulla disperazione e sul valore di un pasto, di un letto, di un sorriso. Sul coraggio, sulla libertà.
Penso al racconto di mia nonna del dicembre 1943, le bombe su casa, un episodio domestico come mille altri con un esito inaspettato e fatale. Penso alle sue parole e ai suoi occhi, a percorsi spezzati e cicatrici che dolorosamente suturano per far germogliare nuova vita. Penso al male, alla ferocia, al paralizzante vuoto emotivo della perdita. Al fragore, al fiato in gola, alle urla. Ai perché. Penso alle parole del Lessico famigliare di Natalia Ginzburg, e mi dico che il mio lessico della guerra esiste e ha dignità qui, tra la vita reale, la memoria che conservo e le pagine di carta. Macerie e libri, pagine nella polvere: voci di uomini che avevano visto, che sapevano, che potevano e forse possono salvarci
La guerra, noi pensavamo che avrebbe immediatamente rovesciato e capovolto la vita di tutti. Invece per anni molta gente rimase indisturbata nella sua casa, seguitando a fare quello che aveva fatto sempre. Quando ormai ciascuno pensava che in fondo se l’era cavata con poco e non ci sarebbero stati sconvolgimenti di sorta, né case distrutte, né fughe o persecuzioni, di colpo esplosero bombe e mine dovunque e le case crollarono, e le strade furono piene di rovine, di soldati e di profughi. E non c’era più nessuno che potesse far finta di niente, chiuder gli occhi e tapparsi le orecchie e cacciare la testa sotto al guanciale, non c’era. In Italia fu così la guerra.