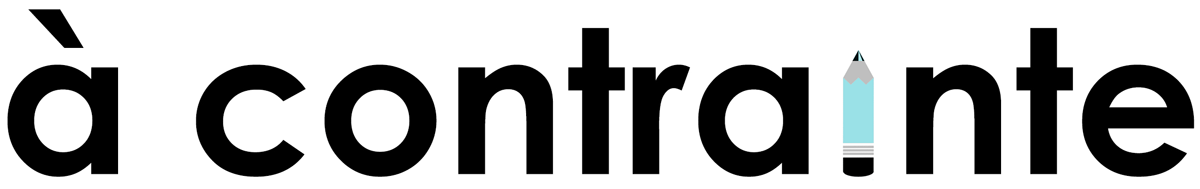Ho un ricordo netto e preciso di quando ho acquistato Il posto di Annie Ernaux (L’Orma Editore, traduzione dal francese di Lorenzo Flabbi) e del perché l’ho fatto. Era aprile 2016 ed ero a Torino, sotto i portici di Piazza San Carlo era in corso “Una rosa di libri. Torino che legge” e una delle tante librerie indipendenti presenti con un banchetto (sono quasi sicura di poter dire che si trattasse di “La gang del pensiero”) esponeva tutti i romanzi della Ernaux. Frenata: curiosità. Curiosità per un’autrice mai letta e scoperta grazie a un’iniziativa di qualche mese prima, intercettata surfando il web e le “cose di libri”: Modus Legendi. Dell’edizione 2017 vi ho parlato qui, ma nel 2016, ai suoi esordi, Modus Legendi aveva proposto di portare in classifica concentrando gli acquisti in una settimana specifica proprio “Il posto”, della Ernaux. Era un periodo un po’ strano, di traslochi e impegni vari, per cui avevo perso l’opportunità di comprare il libro e far parte di coloro che riuscirono in effetti a far sì che un romanzo di qualità finisse nelle classifiche. Ma un lettore, si sa, è mosso da curiosità, e dunque ricordo bene di aver acquistato la Ernaux ad aprile, ricevendo anche una rosa (questa è la consuetudine della manifestazione) e di aver pensato che, seppure tardi rispetto alla data della mobilitazione per la classifica, Modus Legendi era riuscita in qualche modo ad allargare i confini di un libro.
Aprile 2016, febbraio 2017: l’arco temporale in cui il libro ha viaggiato, cambiando posto e salendo o scendendo nella pila delle letture prossime e future. Poi è arrivato il suo momento favorevole, e adesso ve ne parlo, anticipando già che si tratta di un libricino di una potenza folgorante che non mi aspettavo e che mi ha fatto pensare che sì, è un libro di qualità che ha meritato e merita che se ne parli ancora e ancora.
“Il posto” è una storia autobiografica che racconta del rapporto, difficile e segnato da una distanza crescente, tra un padre e una figlia. Questa figlia, che sappiamo dalla quarta di copertina essere la stessa Ernaux, è in realtà una voce femminile che ci racconta in prima persona le vicende e che, secondo me, costituisce il raffinato centro di tutto il libro. Tenetela a mente per dopo. Siamo in Normandia, Francia. Nelle campagne del primo Novecento nasce il bambino e poi ragazzo che diventerà padre dell’autrice. Un garzone di fattoria, cresciuto tra le mura di una famiglia contadina per la quale il valore fondante dell’esistenza è il lavoro. Ed è all’insegna del lavoro che si snoda la vita di questo giovane che, arrivata la guerra, si stacca dal mondo rurale e scopre la città, e il contesto operaio. Inizia così una sorta di scalata sociale che porterà il ragazzo e la moglie a diventare gestori di un bar-drogheria dalle sorti alterne. Due esistenze redente, “arrivate”? No, non è questo il senso della storia, che anzi tiene sempre il riflettore puntato su un atteggiamento, una visione del mondo significative, presenti e ingombranti, piuttosto che sull’effettivo corso di una vita. Trapela tutto da queste parole della figlia, voce narrante:
Sarebbe facile scrivere cose del genere. L’eterno ritorno delle stagioni, le gioie semplici, il silenzio dei campi. Mio padre lavorava la terra altrui, non ha visto la bellezza, lo splendore della Madre Terra e altri miti gli sono sfuggiti.
E la figlia?, vi state giustamente chiedendo. La figlia arriva negli anni Quaranta, in piena guerra. Nata in un periodo buio, cresce e impara, va a scuola e ha buon profitto, prosegue negli studi fino all’università, e sappiamo che poi diventerà insegnante e abiterà a Parigi con un marito e un figlio. Come si legano queste due storie, che di per sé sono asciutte, scarne, essenziali? La mia risposta è: con la scrittura, ciò che rende questo romanzo speciale. La figlia sente la necessità, appena morto il padre, di ricordarne la storia, di ripercorrerne l’esistenza dando spazio a quel “posto” dove l’uomo è nato e ha vissuto, fino a morire, quel posto da cui lei è stata da sempre spinta ad allontanarsi, fino a riuscirci, fino a seppellire le proprie radici e far sbocciare, dalle origini contadine, una donna borghese. Ecco dunque che la voce narrante è colei che scrive, intraprendendo un percorso di ricostruzione della figura del padre. Ci spiega lei stessa come affronta questo compito che si è imposta: colpi di penna essenziali, netti. Non aspettatevi compassione o sentimenti: nella Ernaux non ci sono. C’è anzi un limpido e cosciente lavoro di scrittura che arriva al cuore del rapporto tra padre e figlia senza mai cedere il passo alla personalizzazione. È un racconto asciutto, che nella trama delle sue parole non fa che descrivere l’esistenza di un uomo e della figlia. Ma è la folgorante limpidezza di quelle descrizioni a scoperchiare tutto ciò che non ci viene raccontato. Lo dice l’autrice, leggete e riflettete sul grassetto:
Scrivo lentamente. Sforzandomi di far emergere la trama significativa di una vita da un insieme di fatti e di scelte, ho l’impressione di perdere, strada facendo, lo specifico profilo della figura di mio padre. L’ossatura tende a prendere il posto di tutto il resto, l’idea a correre da sola. Se al contrario lascio scivolare le immagini del ricordo, lo rivedo com’era, la sua risata. E la sua andatura, mi conduce per mano alla fiera e le giostre mi terrorizzano, tutti i segni di una condizione condivisa con altri mi diventano indifferenti. Ogni volta, mi strappo via dalla trappola dell’individuale. Naturalmente, nessuna gioia di scrivere, in questa impresa in cui mi attengo più che posso a parole e frasi sentite davvero, talvolta sottolineandole con dei corsivi. Non per indicare al lettore un doppio senso e offrirgli così il piacere di una complicità, che respingo invece in tutte le forme che può prendere, nostalgia, patetismo o derisione. Semplicemente perché queste parole e frasi dicono i limiti e il colore del mondo in cui visse mio padre, in cui anch’io ho vissuto. E non si usava mai una parola per un’altra.
L’attenzione al linguaggio, specialmente alle parole, è centrale nel definire la distanza che separa l’universo culturale del padre dalla sfera in cui sta radicando e prendendo forma l’identità della figlia, il suo profilo intellettuale e borghese. L’evoluzione della ragazza, e così il superamento della soglia sociale che la porta un gradino sopra ai genitori, supera infatti la cortina dell’apparenza posticcia con e nel linguaggio. Alle orecchie dell’autrice il linguaggio gergale del padre stride, specialmente se utilizzato in contesti in cui buon senso ed eleganza formale lo escluderebbero. Nel linguaggio lei sente la distanza, e con il linguaggio, l’unico strumento che, da studiosa, insegnante e poi scrittrice, ha sviluppato e sa utilizzare al meglio, parla di questa differenza, ne esprime l’essenza, ne narra lo sviluppo. Al linguaggio affida un ricordo asciutto e scevro di emotività nel quale, tuttavia, il senso e il pensiero si esprimono al meglio proprio attraverso le parole. Questa storia è anche e soprattutto il racconto di due identità costruite attraverso le parole e l’attenzione che l’autrice vi rivolge. Tutto sta nel senso e nel significato delle parole: il loro suono, che evoca mondi, contesti, provenienze, e il loro uso sociale, che implica un ragionamento al secondo grado, un cambio di prospettiva e di priorità, una scaltrezza intellettuale che demarca il confine tra classi sociali meno agiate e salda borghesia. Manca l’ironia tra le conversazioni in famiglia, l’ironia che è la marca di un saper conversare, di una coscienza di linguaggio che la “povera gente” non ha, ma che invece trionfa al piano di sopra, tra la borghesia cui la ragazza aspira. Lampante è questa riflessione:
Tutto ciò che riguarda la lingua nel mio ricordo è fonte di rancore e di dolorose litigate, ben più del denaro.
Cos’è se non, in sintesi, la storia di un affrancamento che si sorregge fondamentalmente sulle possibilità di studio e conoscenza avute da una figlia che nota, suo malgrado, e che conosce bene tutte le debolezze dei genitori, il loro rango, il loro atteggiamento, la loro voglia di rivalsa sociale dopo rigori e fatiche imposti dalla miseria? Questa lucida, a tratti anche spietata ma salda coscienza del potere della conoscenza dà a questo testo una forza universale. La figlia vede, conosce ma sa anche soprattutto riconoscere, ed è da qui, dal riconoscimento di un mondo di cui è stata parte, che si distacca, facendo di una vicenda personale lo scorcio di una storia ben più generale, quella del progresso sociale, della corsa del Novecento, ma ancora di più della composizione del mondo per classi sociali, che continuano a essere tali in virtù di barriere invisibili come senso di inferiorità, atteggiamento, visione, linguaggio, sguardo sul mondo.
Nello scrivere, una via stretta tra la riabilitazione di un modo di vivere considerato come inferiore e la denuncia dell’alienazione che l’accompagnava. Poiché quella maniera di vivere era la nostra, persino felice, ma anche umiliata dalle barriere della nostra condizione (consapevolezza che «da noi non è abbastanza come si deve»), vorrei dirne allo stesso tempo la felicità e l’alienazione. E invece, impressione di volteggiare da una sponda all’altra di questa contraddizione.
Alcune situazioni del libro mi hanno ricordato episodi personali, mi hanno fatto rivivere uno stacco generazionale che in passato mi ha punta nel vivo, facendomi spesso sentire incompresa e svilita. Lo stacco era quello con i nonni, che non capivano il mio amare lo studio, il voler fare il liceo classico tagliando fuori la possibilità di un lavoro sicuro dopo scuole più tecniche, il mio passare ore sulle versioni di latino e greco in casa. E via, proseguendo, le domeniche dei tempi universitari passate a studiare, le estati in casa e non al mare per via degli esami, la fatica nel trovare un lavoro solido e le battute “tizia fa l’estetista e prende tot euro a persona, potevi farlo anche tu, avresti vissuto meglio”. Come il motto che è andato avanti per anni: “ma non sei stanca di studiare?”. No, studiare mi piace, penso sia la chiave per costruire cose migliori domani, penso possa fornirmi lenti con cui guardare più lontano del piccolo giardino dove voi siete cresciuti, tra bombardamenti e miseria che non sono certo colpa vostra, ma che vi hanno segnato, portando irrimediabilmente la mia generazione anni luce dalla vostra, alterando priorità nei valori e nelle visioni.
Gli dava fastidio vedermi stare sui libri tutto il giorno, attribuendo a loro la responsabilità del mio muso lungo e del mio cattivo umore. La luce che la sera filtrava da sotto la porta di camera mia gli faceva dire che mi rovinavo la salute. Studiare, una sofferenza obbligatoria per farsi una posizione e non sposare un operaio. Ma che a me piacesse scervellarmi gli sembrava sospetto. Un’assenza di vita proprio nel fiore degli anni. A volte aveva l’aria di pensare che io fossi infelice.
Nel vivere questo stacco irrimediabile, e nel raccontarlo, la Ernaux fa una scelta di linguaggio che a tratti mi verrebbe da definire devastante. È devastante perché è magnificamente, ancora una volta, asciutta, purificata da aggettivazione e barocchismi sintattici. Essenziale: dritta al sodo. Uno dei modi con cui questo espediente è tenuto in vita è l’uso insistito di una costruzione sintattica scarna, che ricorda l’accusativo alla greca e che ha la funzione di limare ancora di più l’elemento personale, la prospettiva emotiva, lasciando spazio a una descrizione scarna, come appunti su un taccuino. Saltano i verbi, la costruzione sintattica: ciò che ne ricaviamo sono pennellate di parole che con vigorosa potenza parlano di parole e specificazioni non dette, perché già contenute in quella manciata di linguaggio:
Un giorno: «I libri, la musica, vanno bene per te. Io non ne ho mica bisogno per vivere».
La distanza è tutta qui: la concezione delle cose, la visione del mondo, il suo colore. Valori, scale, priorità. Orizzonti, mete, conquiste e percorsi. Ma in tutto questo, la storia intera di un secolo e di un mondo, una storia che ogni giorno si ripete, silenziosa oppure più grande, sotterranea o manifesta. Questo per dire, senza fronzoli di parole che appesantirebbero questo mio commento già lungo, che il romanzo della Ernaux dice tutto, e molto oltre il tutto, con poche essenziali densissime e taglienti pagine. Ed è una lettura sorprendente, ricca, che attinge a piene mani da una scrittura vivida e lavorata, da apprezzare e custodire, sulla quale eventualmente ritornare. Parole pesate al milligrammo, constatazioni enormi limitate a frasi secche come quella con cui chiudo, che restituisce la potenza di cui ho cercato di dirvi finora:
Sono scivolata in quella metà di mondo per la quale l’altra metà è soltanto un arredo.