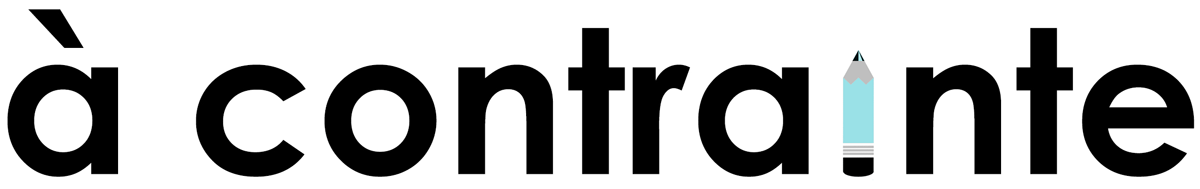https://www.facebook.com/torino.mentelocale.it/videos/995311897271084/
L’edizione appena trascorsa del Salone del Libro di Torino si è aperta il 17 maggio, alle 22.30 della sera, quando in una piazza Castello non troppo affollata perché giocava la Juve, Eugenio Allegri si è affacciato niente meno che dal sontuoso e nobile balcone di Palazzo Madama, e ha letto al microfono alcune pagine da Il nome della rosa e dalle Postille a Il nome della rosa, entrambi, come è noto, testi di Umberto Eco. Questo qua sopra è un video che ho fatto e montato io: due scene dal romanzo, e un intermezzo dalle Postille che si sofferma, in ragione della grande passione per il tema di Eco, sull’interpretazione, e sul significato del titolo, per molto tempo e per molti lettori enigmatico, ma il cui senso si risolve in un pensiero splendidamente semiotico.
Stat rosa pristine nomine, nomina nuda tenemus, è la frase conclusiva del romanzo, e ne restituisce il significato, incentrato sullo sforzo di raggiungere la Verità attraverso l’interpretazione dei segni che il mondo ci fornisce, sempre arbitrari, sempre umani, artefatti di linguaggio: “la rosa primigenia esiste solo nel nome, possediamo soltanto nudi nomi”. Non voglio scrivere un post dove spiego ed esamino tutti i reconditi significati della complessa e profonda opera di Eco. Solo notare una cosa: parliamo di segni, significati e senso. Quindi, riassumendo, parliamo di semiotica. Se non avessi ascoltato Allegri leggere alcune pagine, e se non fosse accaduto quel che vi racconto adesso, forse la mia mente non sarebbe tornata indietro a ripescare quello che sapevo e so del romanzo, e quello che la semiotica mi ha insegnato negli anni (vedi qui), facendo sì che oggi, quando ripenso a Il nome della rosa, non immagino solo una storia truce e oscura, ambientata in una spettrale abbazia medievale, ma sono diventata quel lettore smaliziato di cui Eco parlava nel Lector in fabula, e so perfettamente che ci sono un sacco di cose che l’autore mi suggerisce dietro alla vicenda di Adso e Guglielmo (che, per inciso, resta e resterà il volto superfascinoso di Sean Connery), ci sono citazioni, giochetti, divertissement e persino contraintes, come inserire una storia gialla e una storia di formazione in un romanzo storico, rispettandone le regole fondamentali, oppure come dare nomi di personaggi realmente esistiti a frati coinvolti in losche trame.
Ora, Umberto Eco per me non è solo uno dei più grandi e celebri intellettuali che il Novecento ci abbia donato, è qualcosa di più, che ha a che fare con tanti elementi parte integrante di un unico puzzle. Allo stesso modo Il nome della rosa e le sue Postille hanno rappresentato e sono ancora oggi dei punti di riferimento nel mio percorso scolastico e di formazione. Ecco perché il fatto che il Salone, la manifestazione forse più grande e importante in Italia dedicata ai libri, si sia aperto con le parole di Eco, mi ha riempita di gioia, ed ecco perché ho messo un segnalibro su questo evento e ve ne voglio parlare qua. Il 23 maggio inoltre, il giorno subito successivo alla chiusura del Salone, c’è stata la prima della versione teatrale de Il Nome della rosa, al Teatro Carignano di Torino. Io era là, sul mio sgabello di palchetto, a curiosare come il regista Leo Muscato avrebbe reso un testo complesso, che viaggia già da anni accompagnato da un universo immaginativo e visivo attribuitogli dal film, prima traduzione intersemiotica dell’opera, primo adattamento. Insomma: il Salone del libro e la sua bellissima edizione 2017 sono in qualche modo cresciute dentro una cornice fatta di parole di Eco, del suo romanzo più conosciuto, e siccome in questi giorni ricorreva anche il mio primo anno da addottorata in semiotica, tutto questo ensemble di cose non mi è passato indifferente.
Il nome della rosa è uno dei romanzi preferiti di mio papà. Insieme a poche altre letture “fondanti” lo tiene nel cassetto del comodino da anni, in un’edizione tascabile Bompiani sottolineata e ormai ingiallita. Le cronache familiari narrano che quando ancora la cicogna doveva prelevarmi e portarmi al nido, i miei fossero andati al cinema allora più “cool” della provincia, l’Ariston di Sanremo, a vedere un film atteso, tratto da un romanzo Premio Strega. Era lui, il romanzo di Eco portato al cinema nel film di Jean Janques Annaud, con Sean Connery nella parte del frate-detective Guglielmo da Baskerville. Ebbene, quel film piacque così tanto a mio papà da incuriosirlo sul libro. In poco tempo ne divenne esperto, tanto che anni dopo, in quinta ginnasio, quando mi toccò leggerlo, fu lui a darmi due dritte.
Breve flash back: no, in quinta ginnasio di solito non si legge affatto Eco, il suo posto è occupato invece da Manzoni con i suoi Promessi. Volle il caso, o forse solo una visionaria insegnante decisamente fuori dalle righe, che per ragioni che ho dimenticato parlassimo un giorno di Cuore, best seller ante litteram di colui che dava il nome al mio liceo, Edmondo De Amicis. La prosa di Cuore non andava giù a nessuno, e nemmeno la sua morale. Si sa: gli anni dell’adolescenza. La prof fu dunque decisiva con il suo intervento nel quale ci avvisava che tale Umberto Eco, sì, lui, quello de Il nome della rosa (e chi lo sapeva, allora, che Eco aveva inventato la semiotica, e che la semiotica mi avrebbe in parte cambiato la vita?), aveva scritto un divertente saggio chiamato Elogio di Franti, sulla Bustina di Minerva, raccolta di arguti scritti sui più svariati argomenti, colti e pop. Cioè, uno, un intellettuale, che scrive un elogio del personaggio cattivo di un libro perbenista. Geniale. Fu subito simpatia, tra Eco e la mia classe. Così tanto che sì, ci lanciammo in questa bizzarra proposta irriverente, in barba al programma “Prof, perché non leggiamo Il nome della rosa”? E così avevamo fatto. Ero andata a recuperare l’ingiallito volume Bompiani dal cassetto del comodino, e avevo iniziato la barbosissima lettura infarcita di roba noiosa e pesante. L’avevo iniziata presto, poi l’avevo lasciata, poi, non si sa bene come, era arrivata la minaccia di un compito in classe. Ed era finita che la domenica prima del compito in classe io stessi ancora a metà libro, metà fisica, perché a furia di portarlo in giro e aprirlo, al vecchio volume si era spezzata la rilegatura, fatto che aveva generato due tomi singoli. Alle sei di sera di quella domenica, il libro di Eco non lo avevo ancora finito. In quel momento, il genitore geniale fece una cosa assolutamente da sconsigliare ai meno avvezzi all’arte dell’improvvisazione scolastica. Mi disse: “guardati il film”. Prese la vhs su cui avevamo registrato il film anni prima, mentre lo passavano su Rai1 (eliminando con attenzione le pubblicità), e mi affiancò alla visione, riempiendo le eventuali lacune. Il compito in classe andò benone, non ne ho ricordo e dunque immagino di non aver preso un brutto voto. Solo dopo un po’, alcune settimane, libera dal giogo scolastico, ripresi il secondo volume del doppio tomo, e finii la lettura, con gusto.
Chiusa la parentesi scolastica, il best seller di Eco è rimasto lì, nel suo cassetto, con le sue sottolineature e le sue storie di lettori da raccontare. Di Eco non ne ho più sentito parlare fino all’università, quando ho scoperto tutto il resto. Che, peraltro, era forse il meglio del Professore. Ho letto un sacco di saggi, li ho trovati entusiasmanti, mi ci sono anche divertita. Ho letto le parole di Eco sulla sua stessa attività di scrittura di romanzi. L’ho immaginato, immenso e geniale, isolarsi nel mondo dell’invenzione romanzesca con i testa chiarissimi tutti i processi di interpretazione e creazione di senso che così bene aveva descritto dando corpo alla teoria semiotica. Poi l’ho conosciuto. A Bologna, nel suo mantello invernale con il quale ascoltava proposte e interventi di studenti. A Torino, in aule universitarie gremite e tra il ricordo dei suoi compagni di studi e di collegio. Sempre a Torino, e poi Teramo, e di nuovo a Bologna, per il dottorato, nell’ambito dei convegni che portavano l’allegra congrega semiotica di cui ero misera parte in giro per l’Italia.
 Ne ho un ricordo vivo e bello di due esatti anni fa, quando gli conferimmo la laurea honoris causa a Torino. Erano i primi di giugno, avevamo organizzato un grande convegno che sarebbe terminato con la sua proclamazione. Eco arrivò col suo bastone nel cortile del Rettorato di via Po, prese parte al convegno, lo avvisarono che la lingua ufficiale era l’inglese, e così lui mise via i tre foglietti di taccuino preparati e improvvisò un discorso in uno splendido inglese. Firmò libri, partecipò alle foto di gruppo. Nel pomeriggio ci ritrovammo nell’aula magna in Cavallerizza. I nostri docenti impacciati nelle toghe, il corteo del Rettore e dei professori a celebrare colui che poco dopo proferì in sala stampa le parole sugli “imbecilli del web” che fecero il giro del mondo – e di quello stesso web impazzito. Una volta usciti gli chiedemmo di fare un selfie (imbecilli del web, hai detto?!), il quale campeggia oggi, nel suo bianco e nero, sulla mensola della mia libreria dedicata ai libri di comunicazione. La faccia di Eco, io e i miei colleghi intorno, la stessa passione, l’ammirazione e una sterminata curiosità per il mondo.
Ne ho un ricordo vivo e bello di due esatti anni fa, quando gli conferimmo la laurea honoris causa a Torino. Erano i primi di giugno, avevamo organizzato un grande convegno che sarebbe terminato con la sua proclamazione. Eco arrivò col suo bastone nel cortile del Rettorato di via Po, prese parte al convegno, lo avvisarono che la lingua ufficiale era l’inglese, e così lui mise via i tre foglietti di taccuino preparati e improvvisò un discorso in uno splendido inglese. Firmò libri, partecipò alle foto di gruppo. Nel pomeriggio ci ritrovammo nell’aula magna in Cavallerizza. I nostri docenti impacciati nelle toghe, il corteo del Rettore e dei professori a celebrare colui che poco dopo proferì in sala stampa le parole sugli “imbecilli del web” che fecero il giro del mondo – e di quello stesso web impazzito. Una volta usciti gli chiedemmo di fare un selfie (imbecilli del web, hai detto?!), il quale campeggia oggi, nel suo bianco e nero, sulla mensola della mia libreria dedicata ai libri di comunicazione. La faccia di Eco, io e i miei colleghi intorno, la stessa passione, l’ammirazione e una sterminata curiosità per il mondo.
Eco, quel nome sulla copertina di un libro “per grandi” che vedevo fin dall’infanzia nel comodino, isolato nella posizione speciale dedicata solo a pochi volumi, letti e riletti, era diventato Umberto Eco, il professor Eco. Bizzarra, la vita. È alla luce di questo boomerang che l’altra sera, a teatro, ascoltavo le parole di Guglielmo e dei frati nella preziosa biblioteca dell’abbazia e ripensavo allo scrittore, all’inventore di quel mondo. Eco semiologo, Eco bibliofilo, Eco lettore. Solo un lettore avrebbe potuto affrescare un mondo narrativo così denso e vario, un lettore vorace e appassionati di testi medievali così come di romanzi con protagonista Nero Wolfe, via gli apocalittici, e giù dentro, immerso nella cultura pop. Solo un uomo dalla cultura infinita avrebbe infatti potuto raccontare la biblioteca più ricca al mondo e la sua tragica fine tra le fiamme, disegnando come “assassino” un libro, o meglio chi cercava di custodirlo per impedirne la conoscenza. A rileggerla – rivederla – ora, la storia de Il nome della rosa è ricchissima ed entusiasmante, una scala vertiginosa di piani di lettura, un canestro di strizzate d’occhio del semiologo consapevole, lasciate cadere con finto disinteresse per acchiappare i pesci più accorti.
Ho provato gioia e tenerezza, a teatro, ripensando a tutto questo immenso e meraviglioso viaggio partito da un libro, arrivato al cinema, passato dai miei genitori a me e da me alla scuola, e poi all’università, e al mio modo di vedere il mondo, di pensare ai libri, ai testi, a come e quanto viviamo immersi in universi che non sono altro che grandi sistemi di senso, retti per lo più dal linguaggio, quel casellario di segni che spalanca le porte del reale e perfino dell’indicibile. Soddisfatta delle montagne russe che erano riuscite a intrecciare libri, letture, teatro, traduzioni, semiotica ed estrema bellezza e consapevolezza della sua centralità, mi sono persino chiesta, sorpresa e curiosa, quali fossero le domande di quel famoso compito in classe di quinta ginnasio. Come avrei risposto oggi?!